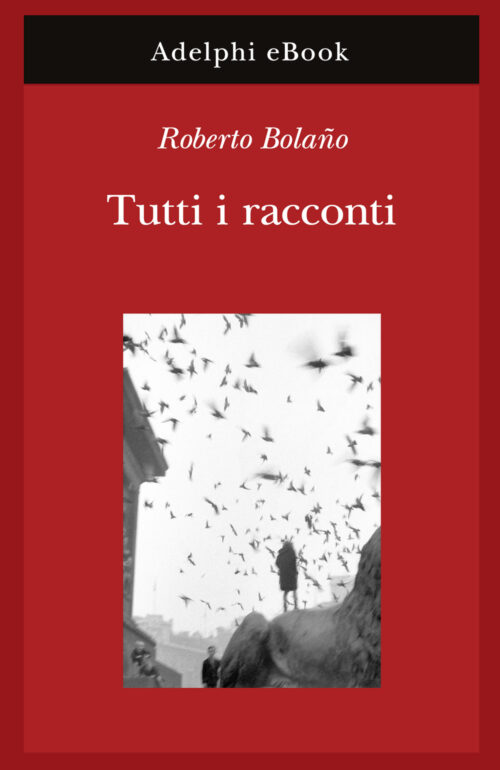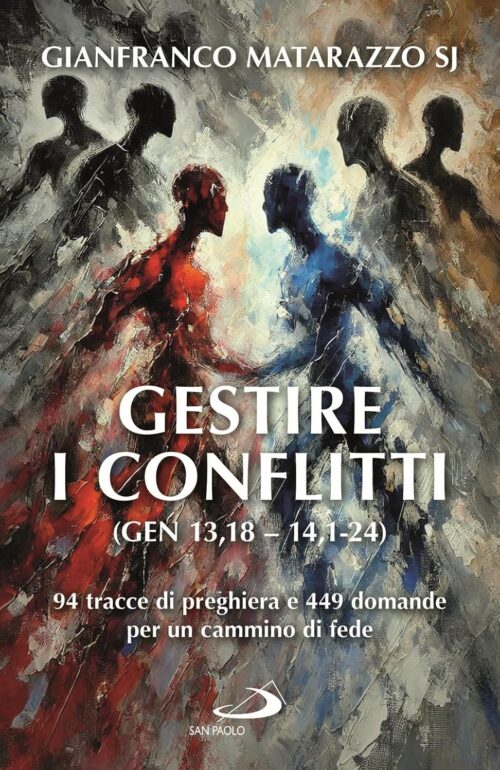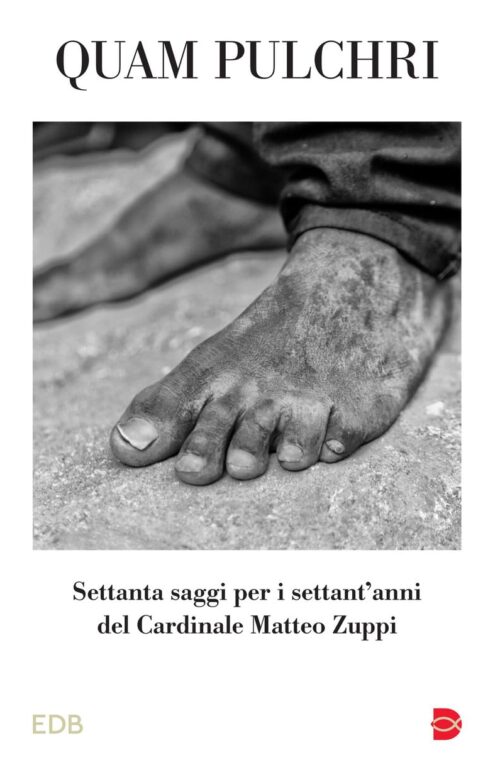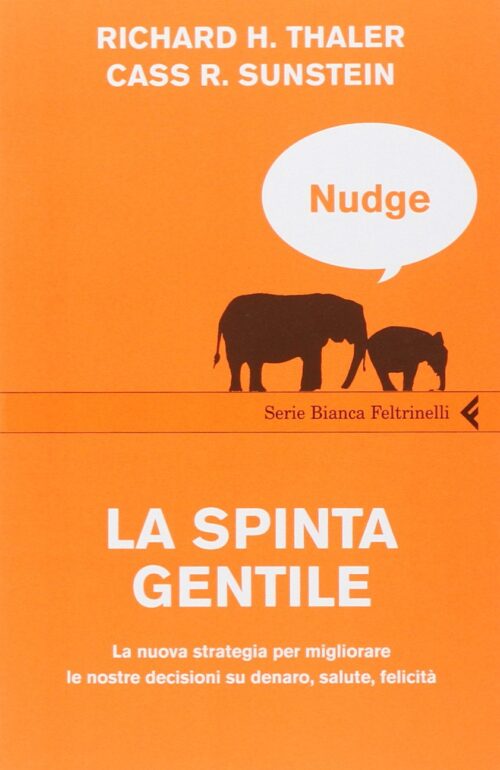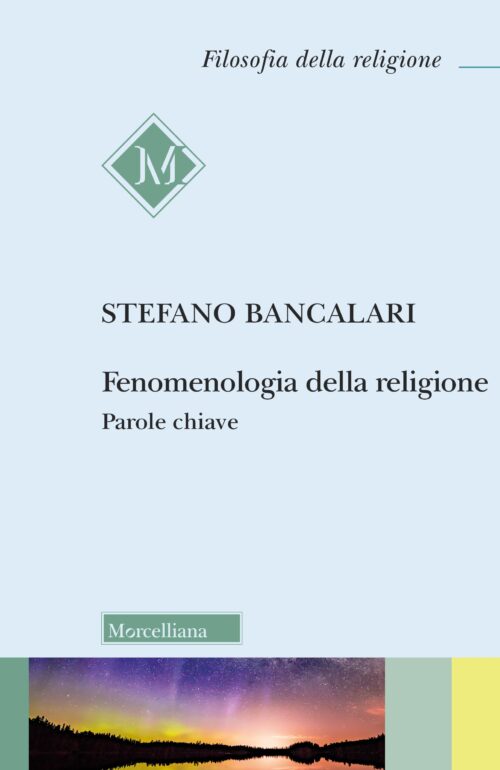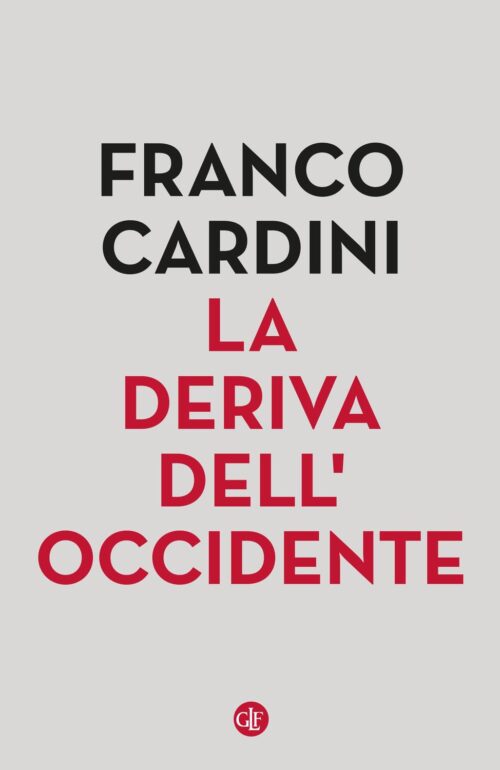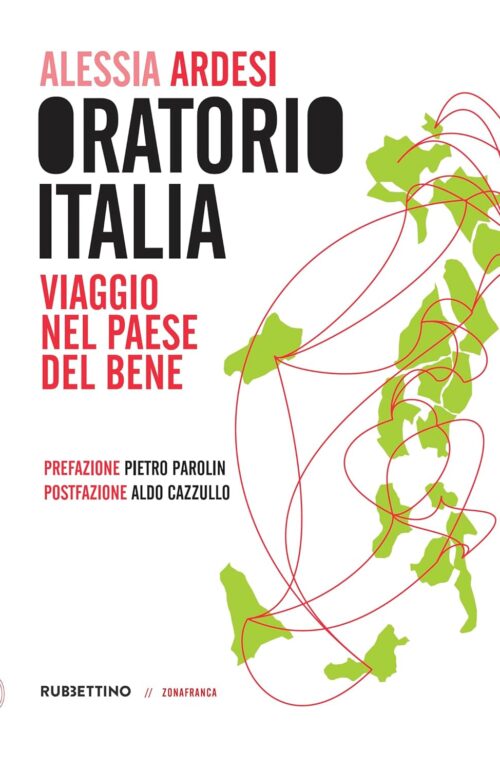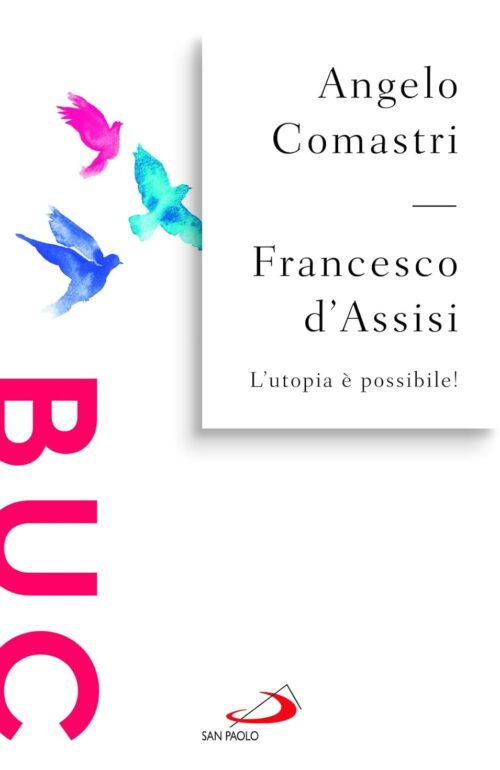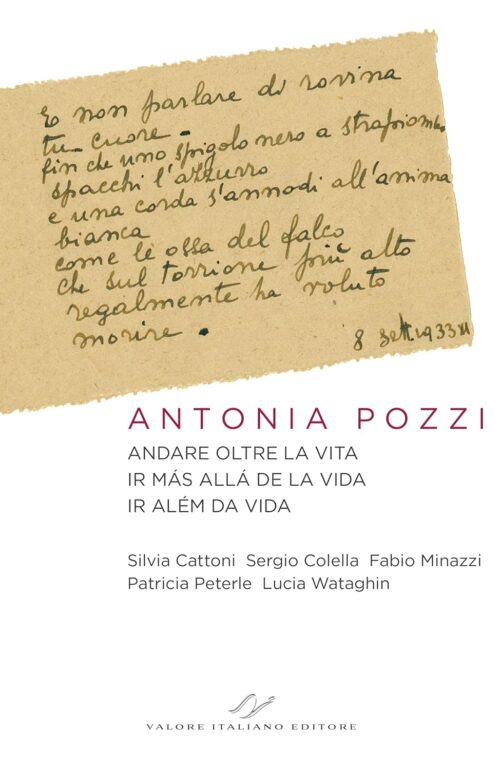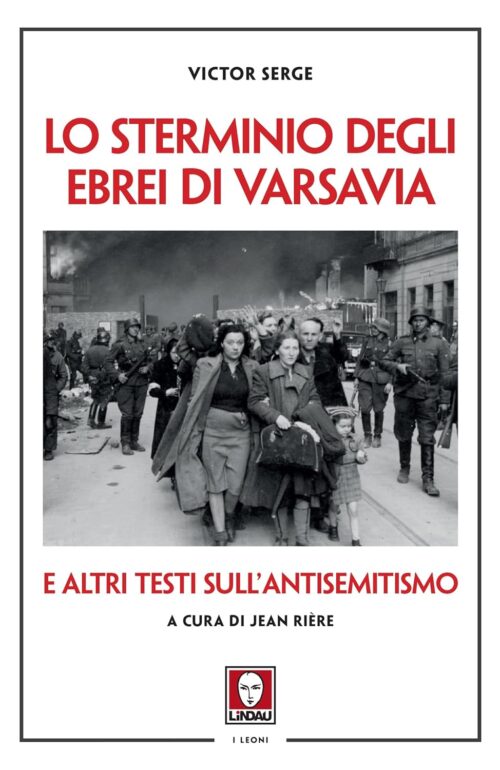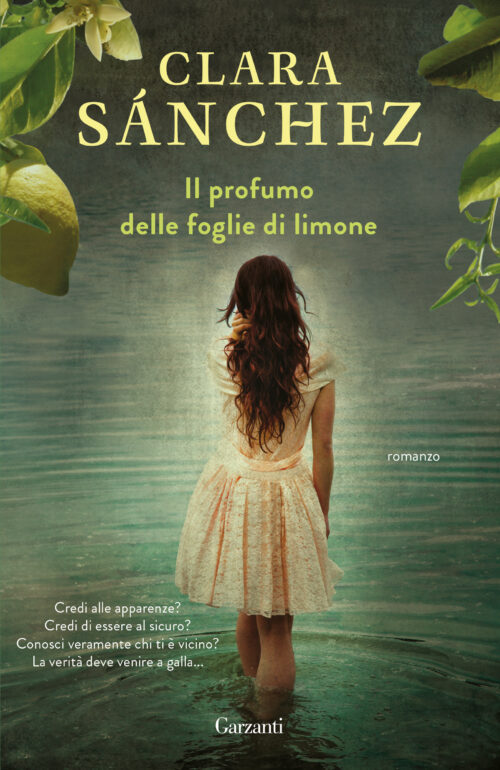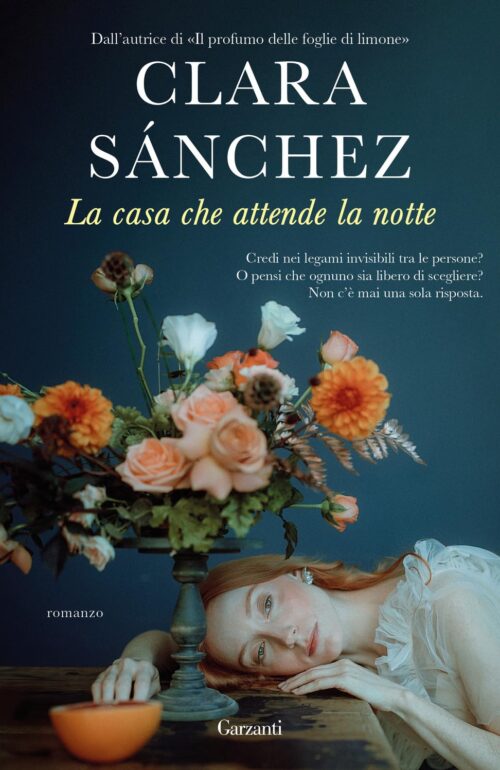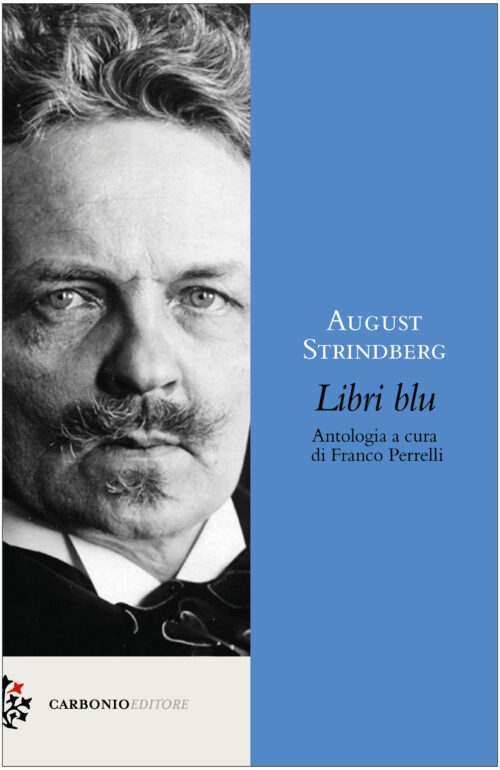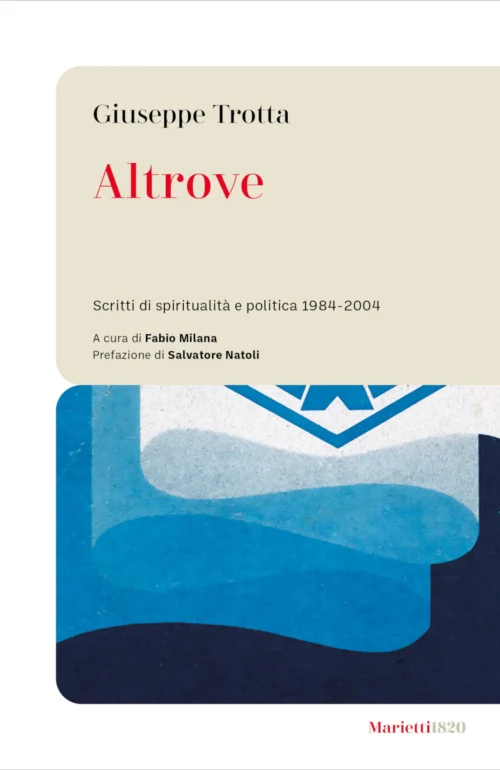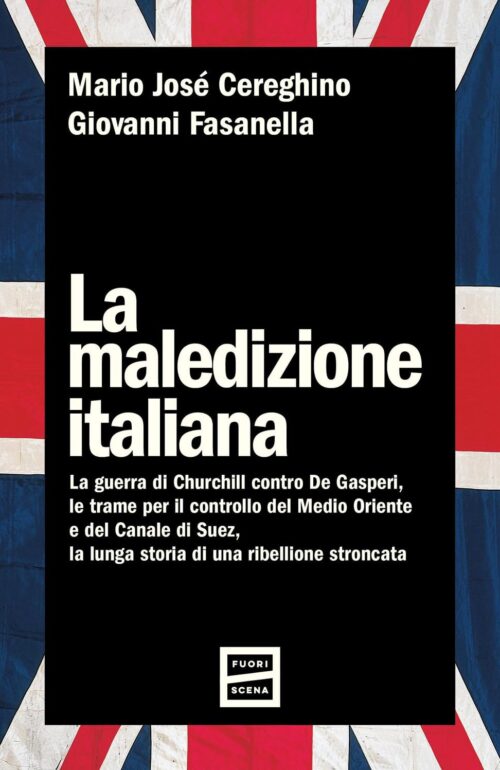In bilico tra passato e presente, l’ultimo album di Eugenio Finardi, Tutto (EFsounds SAS / ADA Music Italy, 2025), come preannuncia il titolo, sembra raccogliere davvero tutte le intuizioni di un cantautore raffinato e visionario che, a distanza di 50 anni dall’uscita del suo primo LP (Non gettate alcun oggetto dai finestrini, 1975), torna sulla scena con una meditazione sul destino dell’umanità. Basta scorrere le 11 tracce – tutte inedite – per rendersi conto della fedeltà, da parte di Finardi, ai temi che hanno segnato la sua lunga produzione. Dalle leggi della fisica, descritte in «Bernoulli» e in «Onde di probabilità», al rapporto tra padri e figli, cantato nella struggente e intimistica «La battaglia» o nel duetto con la figlia Francesca (in arte, «Pixel») in «Francesca sogna», il cantautore milanese si avventura in una rilettura sapiente del proprio percorso biografico e musicale, che prende forma in un mosaico di suggestioni aperto al dialogo tra le generazioni.
In Tutto, lavoro discografico che ha visto la preziosa e ormai storica collaborazione del chitarrista e produttore Giovanni «Giuvazza» Maggiore, è difficile distinguere ciò che è ricordo da ciò che è attualità, come pure risultano inseparabili, all’interno del flusso meditativo che l’album disegna, l’analisi lucida del proprio tempo e la volontà di sognare un mondo diverso. Intorno a questa tensione si sviluppa, ad esempio, il brano «I venti della luna», in cui Finardi prova a guardare la civiltà umana «dall’alto», dalla prospettiva del nostro satellite, la Luna, tanto vicina alla Terra da condividerne in qualche modo il destino, ma sufficientemente lontana per rappresentare la promessa, e la possibilità, di un’alternativa al disastro planetario.
Nella prima traccia, intitolata non a caso «Futuro», il bilancio che il cantautore fa degli anni che lo separano da quell’«extraterrestre» protagonista dell’omonimo brano del 1978 è affidato ai pochi versi che introducono di fatto l’intero album: Ormai s’è capito che / non esistono gli extraterrestri / che ci vengono a salvare / ormai la mia unica speranza / è nell’intelligenza artificiale. La sottile ironia che pervade il brano «Futuro» può essere interpretata, in fondo, come fiducia in un’umanità che, grazie all’uso sapiente della tecnologia, può diventare davvero sempre più interconnessa: Tutti interconnessi a livello molecolare / nanobiologie nel tessuto cerebrale / potremo volare. […] Fare salti eccezionali / sentire quello che sentono / tutti gli altri esseri umani / non aver nemici / e non sentirsi mai più strani / entreremo in connessione / con l’universo e il senso / dell’amore.
In generale, allo spessore tematico che in alcuni brani si addensa in sonorità cupe che non lasciano intravedere alcuna via d’uscita (come nella meditativa e profetica «Pentitevi») fa da contraltare l’atmosfera fluida delle sonorità elettroniche e acustiche, che in canzoni come «Tanto tempo fa» si tinge addirittura di rock. In «Tanto tempo fa», ad esempio, sia pure con leggerezza, Finardi non teme di confrontarsi con le ideologie che hanno segnato un’intera stagione personale e collettiva, ideali oggi in parte scomparsi, ma la cui eredità e ambivalenza sono ancora da ripensare: Alla radio ho sentito un sogno che non si è ancora spento / di giustizia e di speranza / di dignità e uguaglianza. […] Poi l’amore libero / non c’era la proprietà / ma era tanto tempo fa / era tanto tempo fa.
In definitiva, in un tempo come il nostro per certi aspetti povero di speranza, la sensibilità di Finardi ci restituisce – in chiave cantautorale – una visione dell’umano piena di fiducia, non solo nell’intelligenza – umana e artificiale –, ma anche nell’esercizio, spesso salvifico, di quella facoltà propria della nostra specie che è – e resta – la «facoltà dello stupore»: Lascio che la mia mente vaghi / senza sapere dove andrà a finire / la facoltà dello stupore / cerco di trovare il senso del reale / anche se mi fa male / vibrare insieme in sintonia/ che sia questo l’amore («La facoltà dello stupore»).