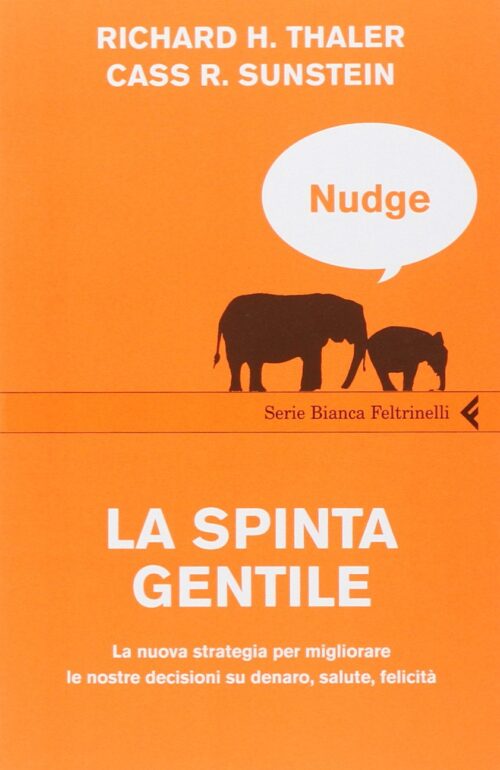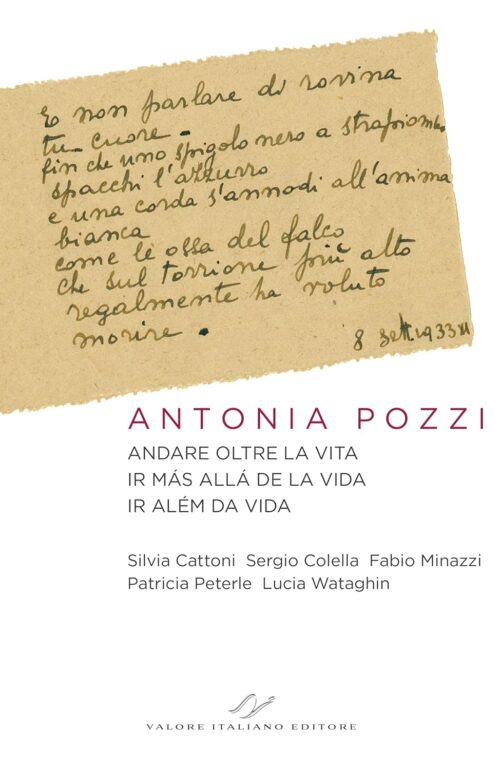Il duo artistico Piers Faccini e Ballaké Sissoko ha pubblicato l’album Our Calling, un interessantissimo connubio di voce, chitarra e kora, che crea un incrocio di melodie e atmosfere che riecheggiano tra le latitudini del mondo, proprio come le culture che si portano dietro i due musicisti. Piers Faccini, angloitaliano che vive nel sud della Francia, incontra Ballaké Sissoko, maestro di kora e cantante maliano: la chitarra – una Martin del 1945 e una Guild M-75 Aristocrat del 1950 – incontra una kora, un’arpa-liuto, di 21 corde, strumento tipico dell’Africa Occidentale, utilizzato dai griot, ossia cantastorie, aedi che cantano e narrano i cicli legati alla vita, all’amore e alla morte.
Faccini e Sissoko si sono incontrati circa vent’anni fa, hanno collaborato e suonato insieme in diverse occasioni, ma solo ora hanno deciso di incidere in uno studio di Parigi: in cinque giorni, sotto la guida di Frédéric Soulard, musicista e ingegnere del suono, hanno registrato le 10 tracce dell’album. Insieme ai due artisti, troviamo alcuni amici e musicisti che impreziosiscono con i loro strumenti i brani musicali: Vincent Ségal al violoncello, Badjé Tounkara al djeli ngoni, Malik Ziad al guembri, strumenti etnici africani a corde.
Per descrivere la musica contenuta in Our Calling, possiamo utilizzare le parole stesse di Faccini: «Se le mie canzoni fossero mappe, vorrei che potessero estendersi dalle brughiere inglesi alle dune del Sahara, passando per le pianure del Mediterraneo». (https://www.accordo.it/article/viewPub/108416). E così il brano di apertura, «One Half of a Dream», apre al sogno, all’incanto, suggerendo il modo di ascoltare questa musica, con calma, tranquillità, senza la fretta che contraddistingue la postmodernità. Su un semplice giro melodico la domanda è diretta, esige subito una presa di posizione: What will you do when the storm comes your way? / Will you run to the high ground or battle the fray? («Cosa farai quando arriverà la tempesta? / Correrai verso un luogo più sicuro o affronterai la tempesta?»).
Nella seconda traccia, «I wanted to belong», un coro struggente per la sua semplicità diviene quasi un mantra che entra sempre più in profondità, mentre le improvvisazioni di kora ci trasportano in un’altra dimensione, onirica e antica, in cui vibrano echi africani, di viaggi, ma anche di fughe, come esprime anche il canto: I want to feel the ground / The way her weight resounds / Longing for steps / The ones that I have left («Voglio sentire il terreno / Il modo in cui il suo peso risuona / Desiderando i passi / Quelli che ho lasciato»).
I testi delle canzoni sono pervasi da immagini cosmiche, di natura, rupestri, che rimandano a un’idea di un mondo ferito, segnato profondamente dal dolore: allodole che si posano su rami secchi (Borne on the Wind), lune tristi (Mournful Moon), cieli scuri (Shadows Are). Tuttavia questa situazione non è l’ultima parola, come mostra il brano «Go Where Your Eyes», in cui forti sono le immagini di una ricerca, di un cammino verso un nuovo senso dell’esistenza, che ha inizio nell’aver attraversato il limite, la fatica e il dolore: Go there nowhere tear down stars / In between light through the bars («Va’ lì dove non si abbattono le stelle / Tra la luce che filtra dalle sbarre»); How the fever bled night from me / Now the fire’s out I see («Come la febbre mi ha prosciugato la notte / Ora che il fuoco è spento, vedo»).
Our calling, dunque, diventa una chiamata al plurale, una nuova vocazione, un imminente appello ad ascoltare e vedere i segni dei tempi, con calma, attenzione e profondità, come suggeriscono le atmosfere musicali, ripetitive, lente ed equilibrate. In un mondo ad alta velocità, è importante imparare di nuovo ad ascoltare i suoni della natura e il ritmo del proprio cuore.