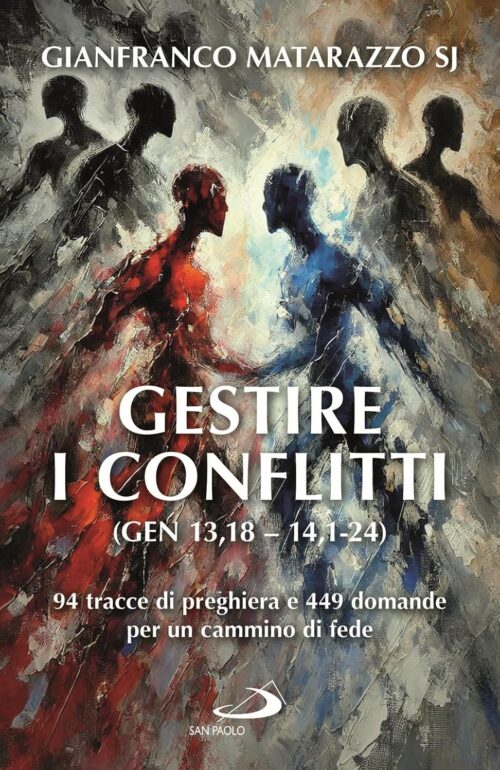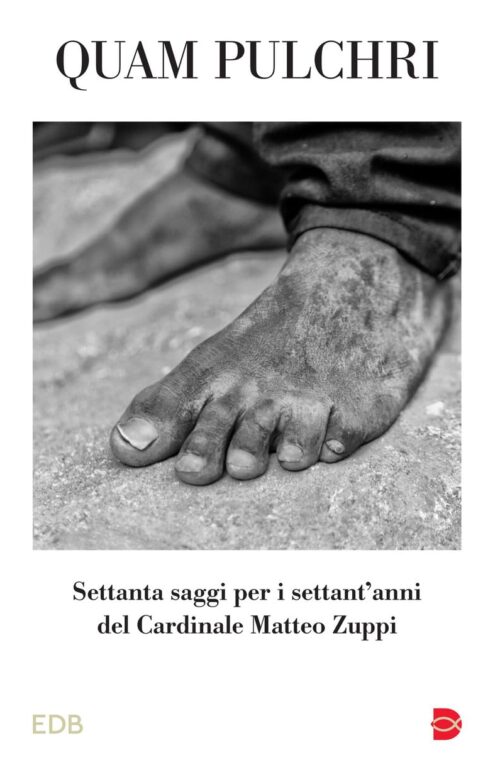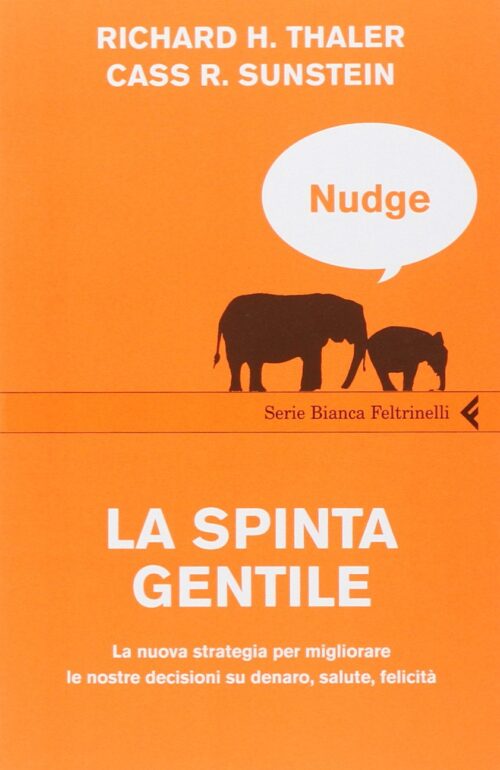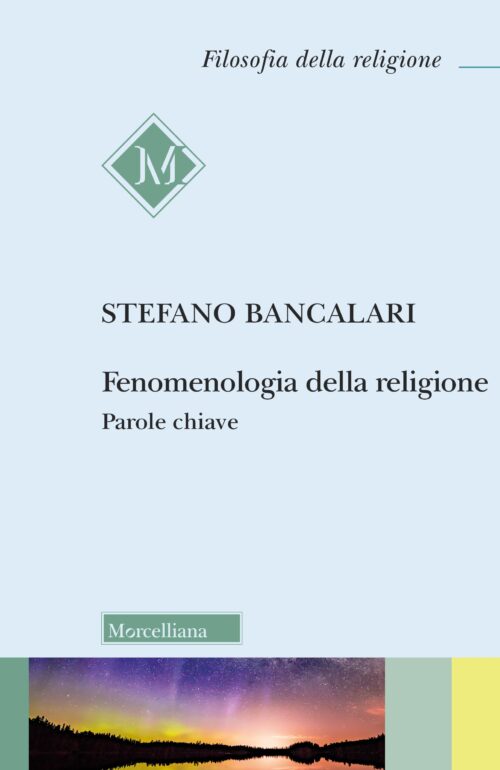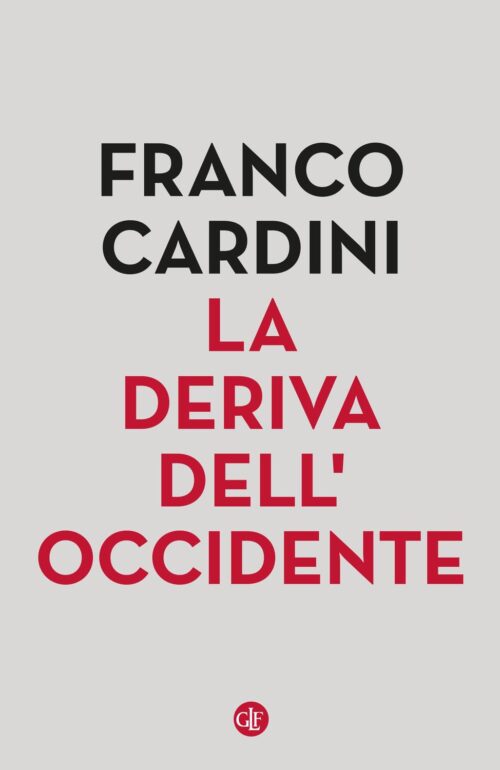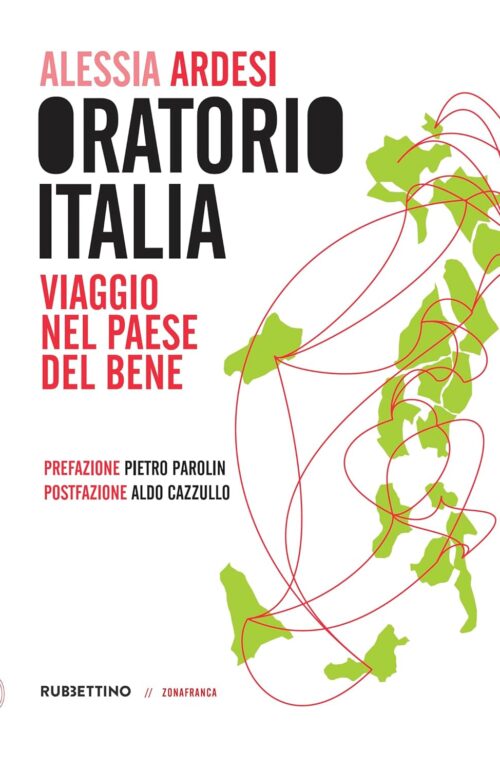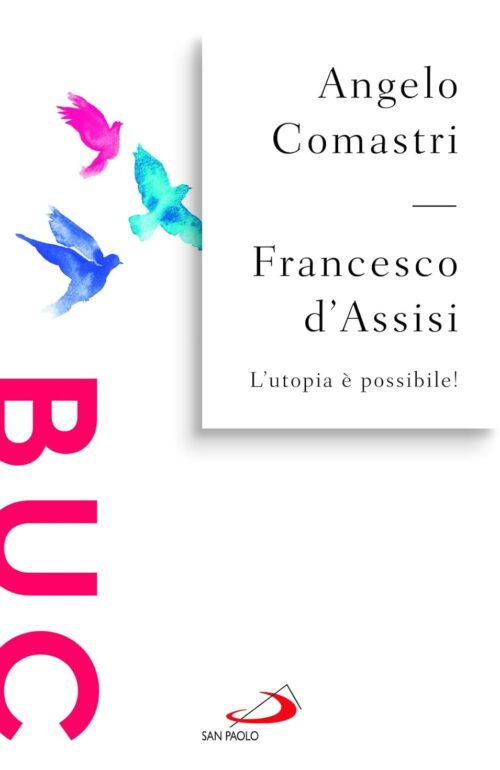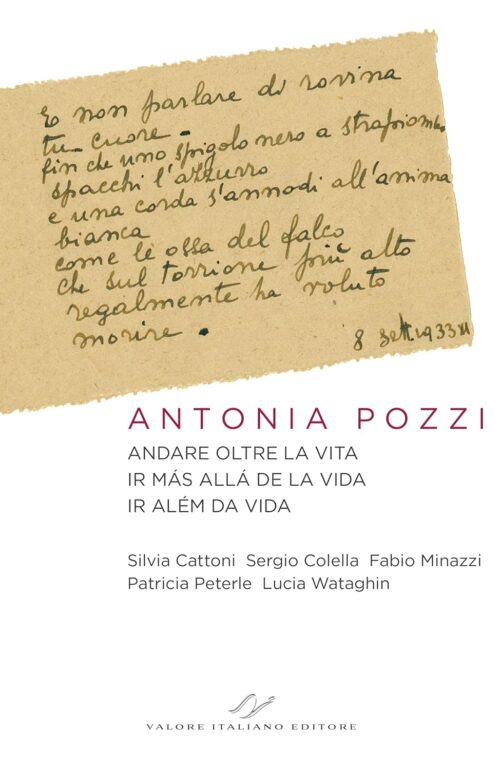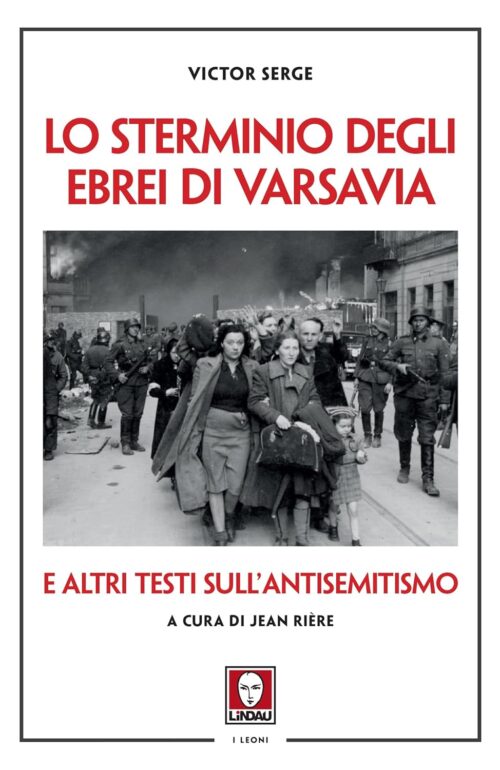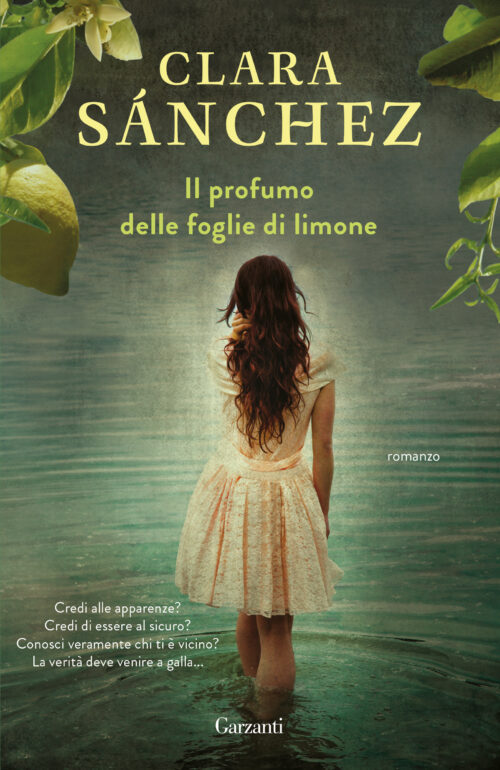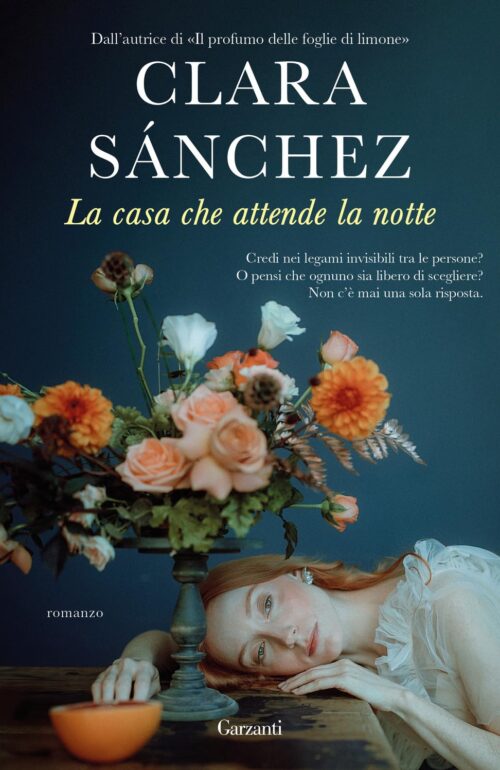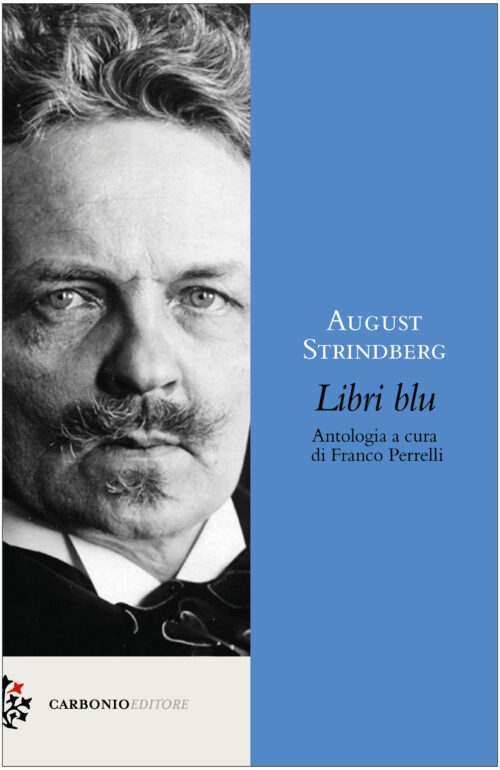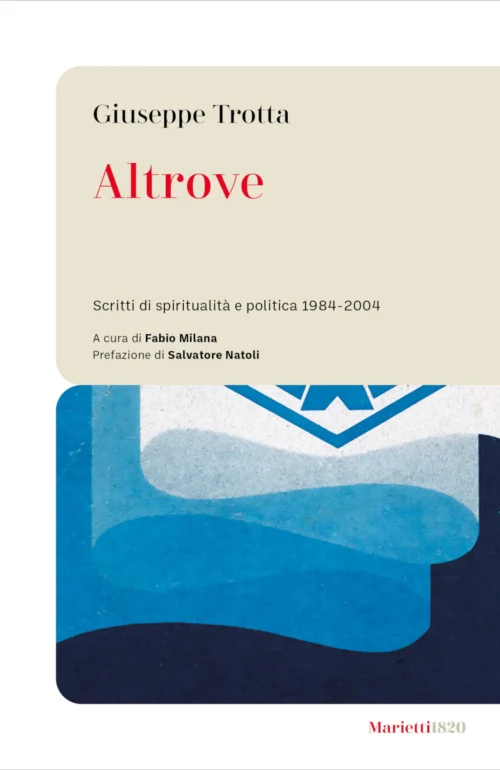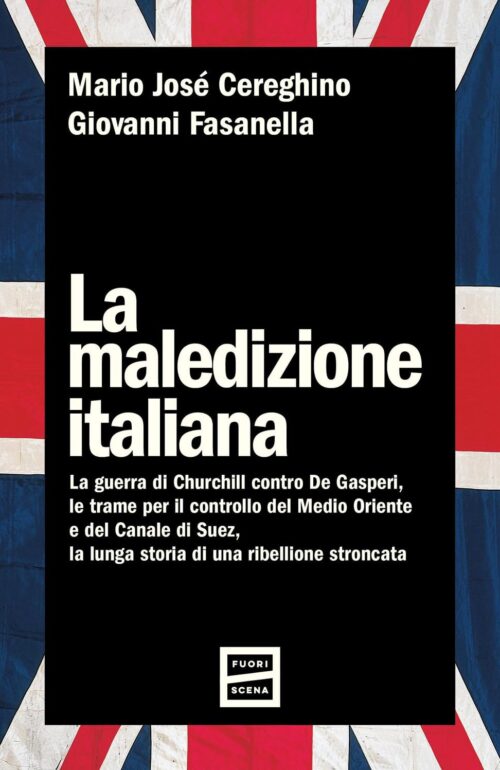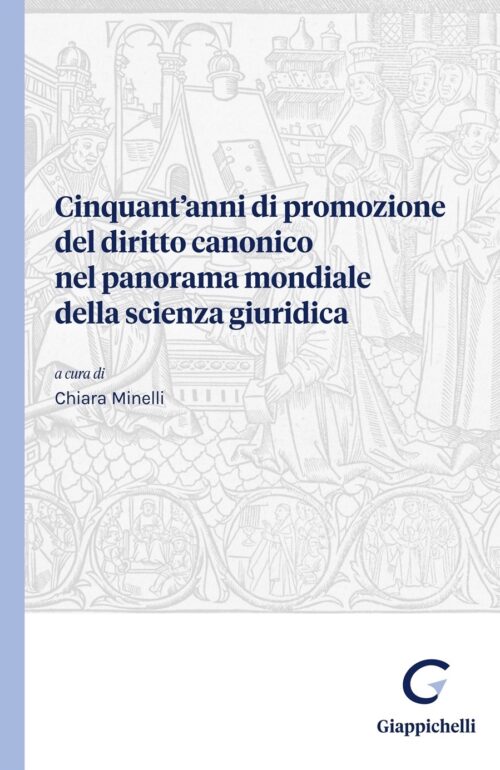Nel cuore della zona Tiburtina di Roma, esattamente il 26 ottobre 2024, apriva i battenti la Fondazione D’ARC, centro polifunzionale dedicato alla promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. La particolarità di questa Fondazione sta nel fatto che sorge in un’area di circa 6.000 mq che prima ospitava una fabbrica di manufatti in cemento, poi abbandonata. Questo «relitto completamente svuotato in attesa di un progetto» è stato riqualificato e portato a nuova vita grazie alla volontà dei coniugi Giovanni e Clara Floridi, che hanno saputo cogliere le potenzialità del luogo, trasformandolo da fabbrica industriale a fabbrica per l’arte.
La struttura a navate non può non ricordare una cattedrale. Spiccano in modo particolare l’architettura portante composta da putrelle e capriate sagomate in ferro di colore giallo, i grandi finestroni con telai verniciati e la presenza dei vecchi carroponti della fabbrica, ricollocati non solo per ricordare la vocazione originaria del luogo, ma anche per l’utilizzo nel trasporto delle opere d’arte. Come ha sottolineato anche la curatrice Giuliana Benassi, il pregio maggiore dell’edificio è sicuramente la possibilità di disporre di ampie superfici e spazi facilmente adattabili alle diverse esigenze espositive.
La collezione permanente, di rilievo nazionale e internazionale, spazia dagli anni Cinquanta del Novecento, passando per l’Arte povera e la Transavanguardia, fino ad arrivare ai nostri giorni. Proprio grazie alla possibilità di attraversare gli ambienti senza una direzione precisa, le opere non seguono un classico «percorso cronologico», bensì sono poste per gruppi al fine di creare un dialogo tra esse e suscitare riflessioni personali nello spettatore che le osserva. Un esempio emblematico si trova già all’ingresso con le opere di Chiara Camoni Sister (Falena) del 2023 e il quadro Slide with me del 1960 di Roberto Sebastian Matta che si richiamano a vicenda per le forme e le tonalità di marrone.
Se si prosegue, ci si imbatte nel confronto tra due linguaggi distintivi del secolo scorso: l’Arte Cinetica Italiana e la Pop Art. La prima utilizza materiali come alluminio, PVC, vetri, specchi e interagisce con lo spettatore attraverso forme di illusione ottica e di impressione plastica del movimento, come testimonia il Ludoscopio n.48 Pozzo di Paolo Scirpa (1979) che crea una profondità fittizia e un «iperspazio» di luce, la seconda, invece, fa proprio il linguaggio dei mezzi di comunicazione e delle illustrazioni pubblicitarie.
Non potevano poi mancare le opere della Scuola del Pastificio Cerere – che era ubicato non distante dalla Fondazione – gruppo artistico romano degli anni Ottanta, in dialogo con artisti contemporanei, quali Mounir Fatmi, che con il suo Coma Manifesto 04 (2017) indaga il linguaggio nella sua «gravità» e «corporeità» attraverso le lettere che sembrano cadute dall’opera e poi sparse sul pavimento.
La sala successiva colpisce subito per il colore nero che accomuna le opere ponendole a confronto, nonostante siano di periodi differenti, e, al tempo stesso, conferisce un forte senso di inquietudine, come emerge da Massacro n.1 di Emilio Vedova (1959).
Una piccola corte esterna fa deviare lo spettatore proponendo diverse opere contemporanee: di forte impatto l’installazione di Giovanni Manfredini (2013) che, tramite spunzoni di ferro, genera un’ombra sulla parete scrivendo la parola «VIVI» e la scala in neon di Massimo Uberti (2012) che sembra voler suggerire una via di fuga verso il cielo.
Una volta rientrati, si apre una sala caratterizzata da diversi stili artistici, dai tubolari realizzati con tappi di bottiglia che pongono l’accento sulla necessità del riciclo, all’opera «femminista» realizzata con collant di nylon dall’artista africana Turiya Magadlela (2019). La sala 9 è sicuramente di impatto poiché dà voce a chi per lungo tempo non ha avuto voce, attraverso materiali di varia natura, come ad esempio i sacchi di juta contenenti il grano che sembrano voler denunciare secoli di sfruttamento della popolazione nera (BA di Ibrahim Mahama, 2014) e il collage di pezzi di camera d’aria tesi su piastrelle, una sorta di grande carta geografica del continente africano che «grida» la colonizzazione subìta (Africa nova descriptio di Diamante Faraldo, 2004).
Questa breve carrellata intende far emergere la qualità e la quantità delle opere presenti che dimostrano come questa Fondazione abbia dato una nuova centralità all’arte e alla cultura, anche attraverso mostre di artisti emergenti e residenze d’artista, in un quartiere semiperiferico della città, caratterizzato da edifici anonimi e a prevalente vocazione popolare, dove le situazioni di disagio sono frequenti. Da segnalare infatti le numerose attività proposte alle scuole di vario ordine e grado che hanno il fine di educare alla bellezza, a una visione altra, soprattutto quei bambini e ragazzi che vengono da contesti difficili, perché si vuole credere che «La bellezza salverà il mondo». Ci auguriamo che la lastra marmorea di Alberto Garutti posta all’ingresso con la frase Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora (2004) possa accoglierne sempre di più.