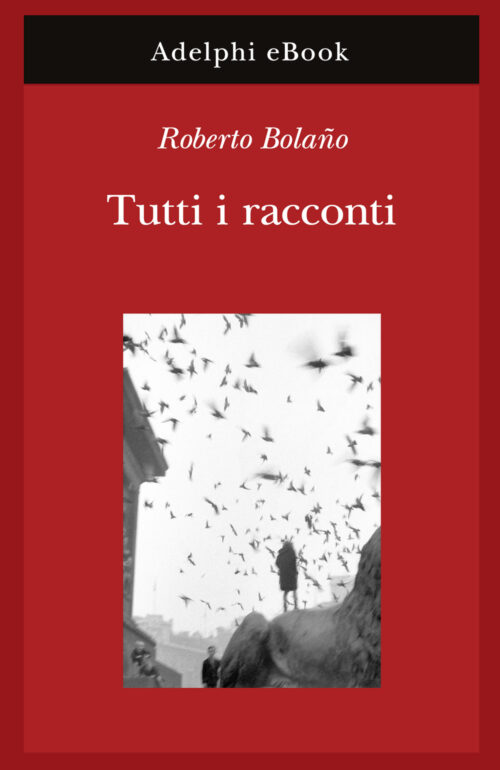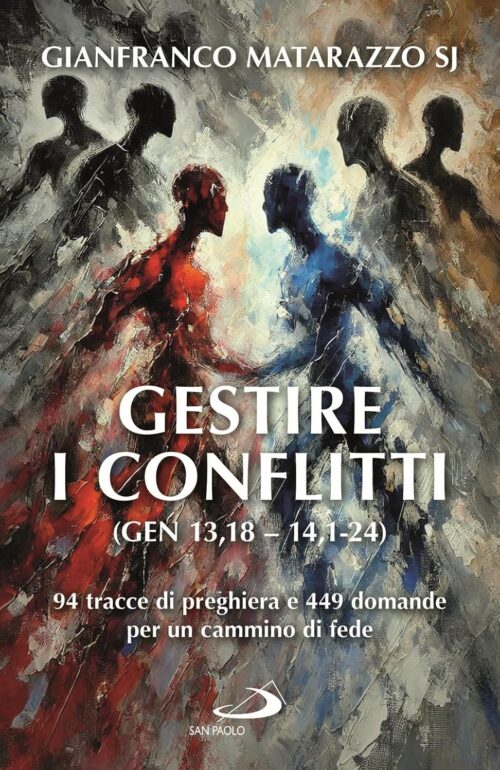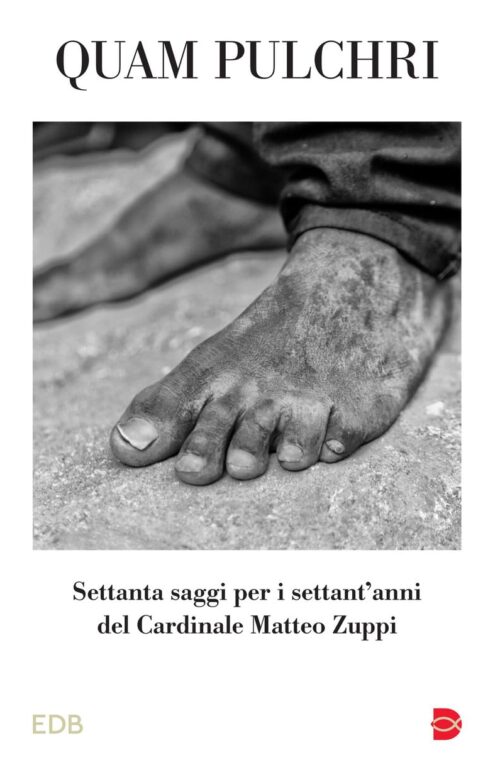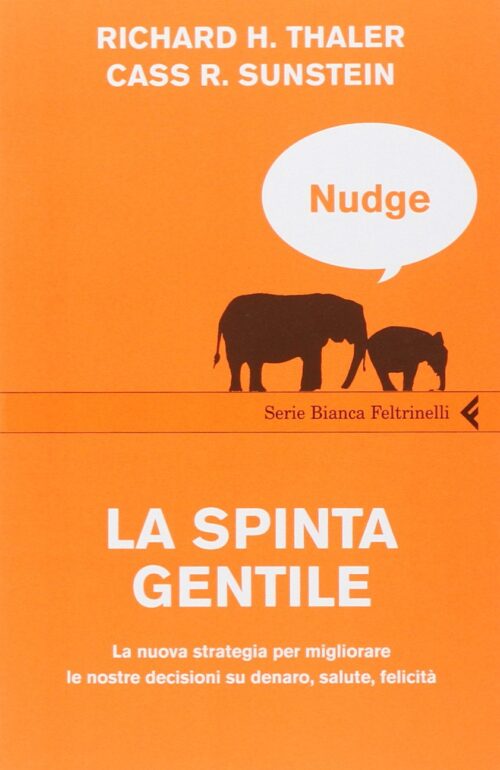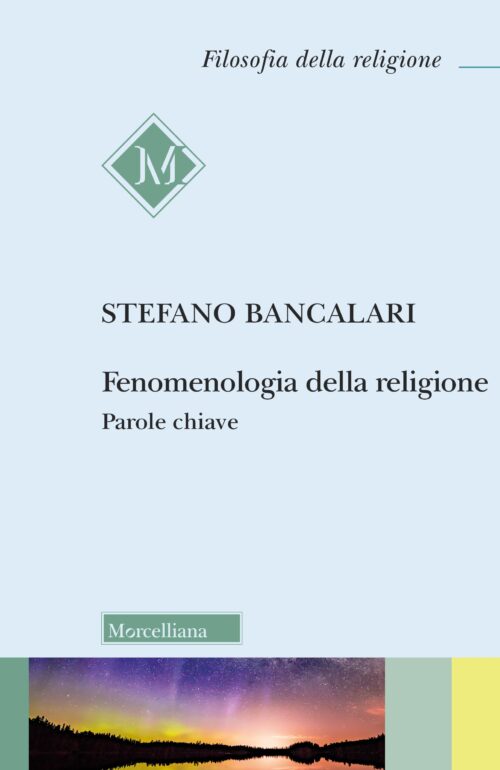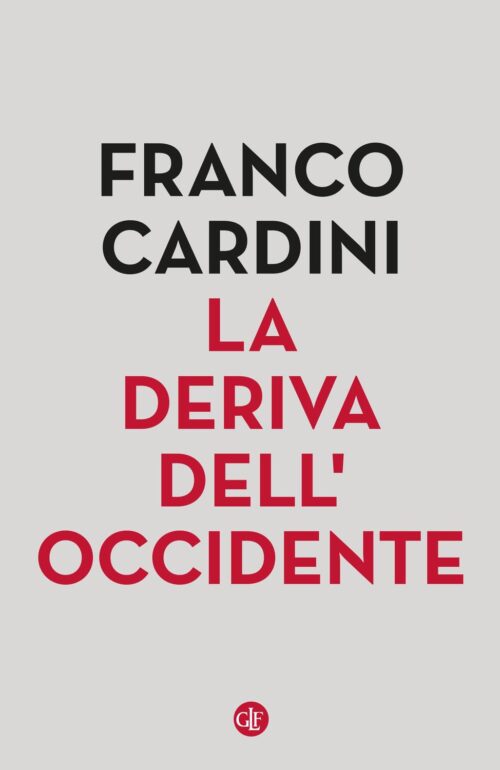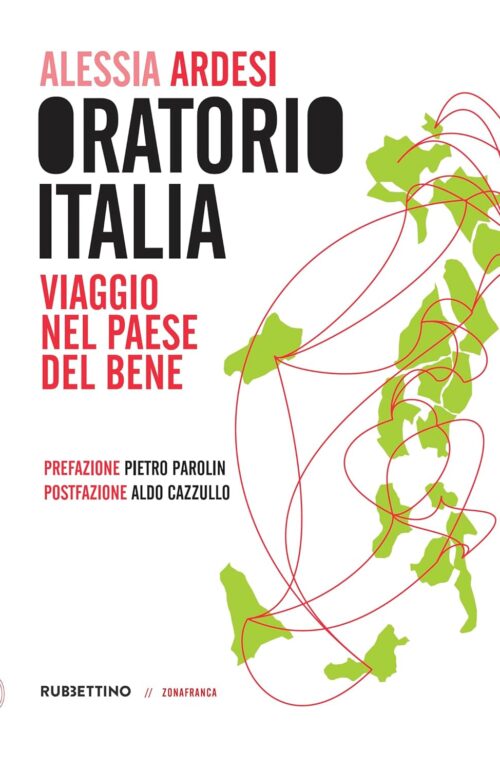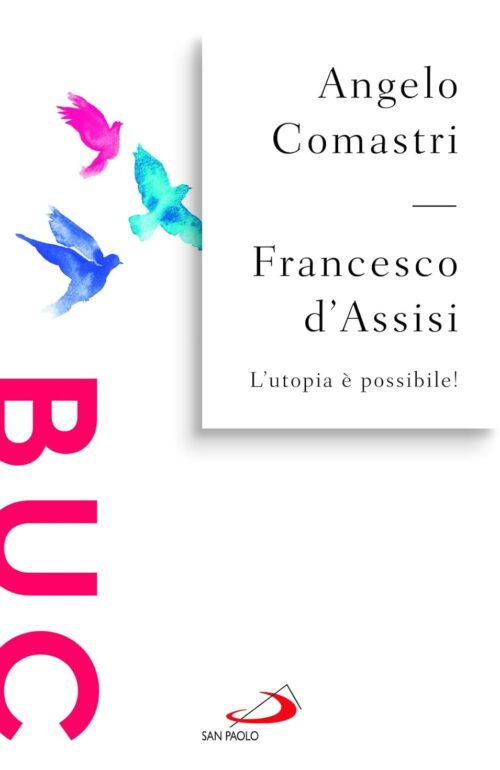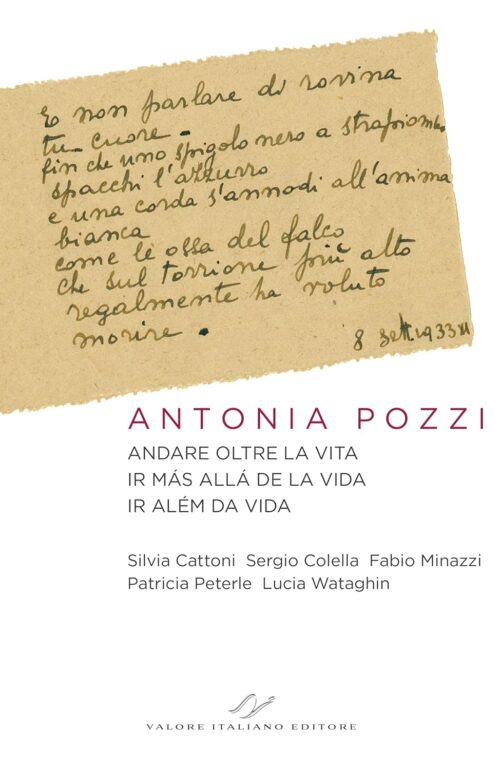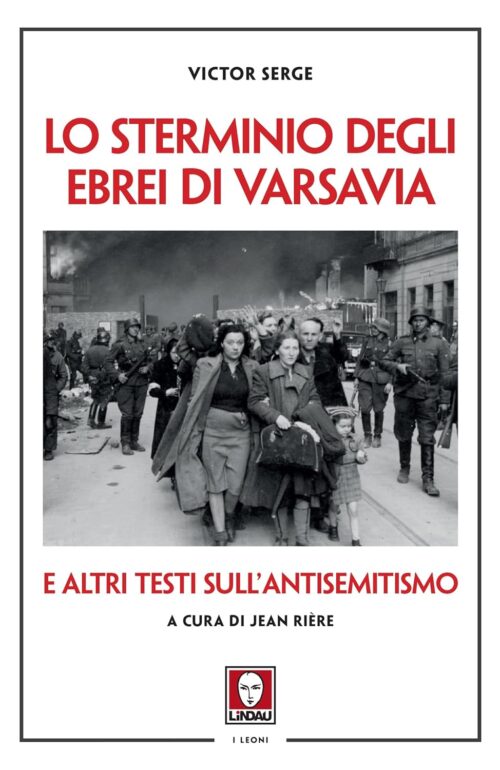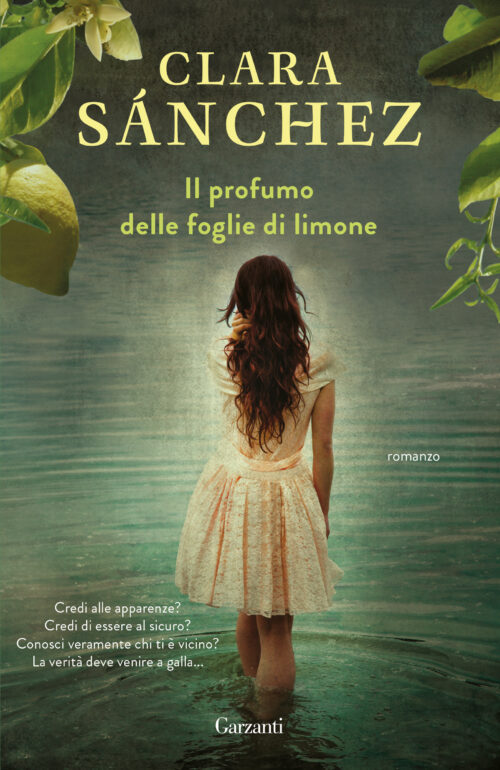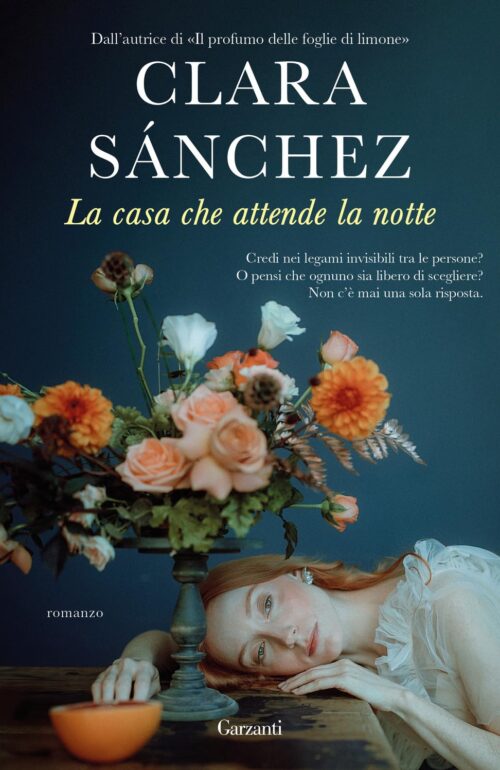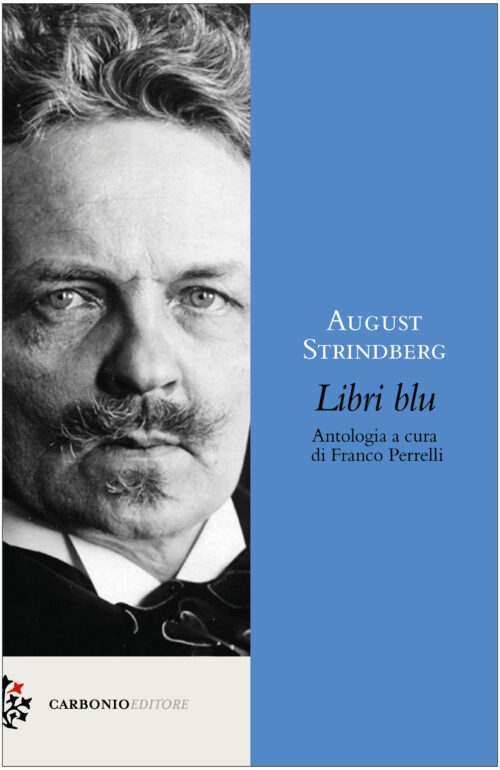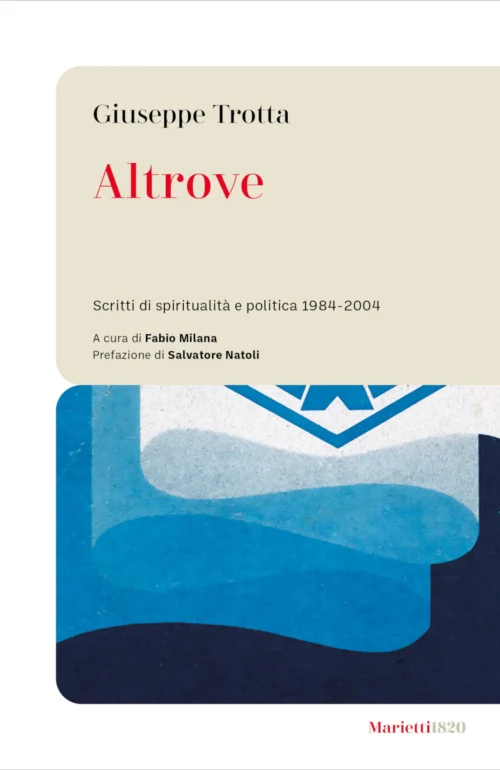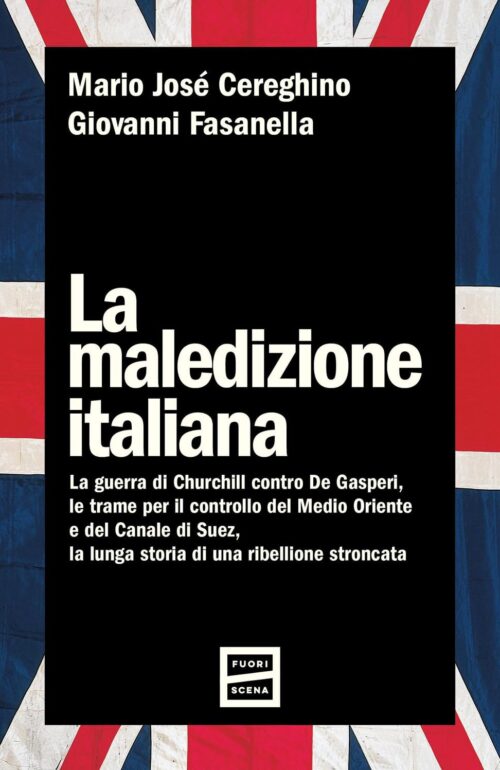La Divina, Eleonora Duse, è stata, per il teatro e per la storia dello spettacolo, un’onda sismica in grado di scatenare una serie di terremoti artistici che hanno contribuito in modo essenziale alla nascita del Novecento teatrale. Una placca tettonica che, scontrandosi con alcuni imponenti protagonisti dell’epoca quali Gabriele D’Annunzio, Adelaide Ristori e altri, ha provocato una rivoluzione dell’arte teatrale e dello spettacolo dal vivo dagli esiti indelebili.
Numerosi studi specialistici hanno illuminato e messo in risalto la straordinaria capacità di Duse di mettere in crisi mentalmente lo spettatore, creando smottamenti nelle sue convinzioni, dando vita a emozioni forti, complesse, attraverso uno studio e una ricerca che partivano dal corpo, spesso da alcuni suoi dettagli. In molte foto della Divina, lo studio delle sue mani rivela, ad esempio, quanto le tensioni muscolari contribuissero a rendere il suo corpo vivo in scena, ovvero, come afferma Mirella Schino (una delle studiose italiane che si è occupata più a fondo dell’universo Eleonora Duse), qualcosa di magnetico, «di imprescindibile per chi guarda».
Ma cosa c’entra questo con il documentario di Pietro Marcello? A visione avvenuta, nulla. Infatti, non è intenzione del regista restituire la biografia della Divina, ma piuttosto catturarne l’essenza, l’anima irrequieta e il fuoco sacro che la rese leggendaria. Perciò egli si affida all’attrice protagonista Valeria Bruni Tedeschi, al cui estro artistico cede in toto questo compito, sostenuto da una sceneggiatura che copre non il periodo della sua consacrazione artistica, ma gli anni dal 1921 a prima che Duse partisse per gli Usa, dove visse fino alla morte.
La cifra stilistica dell’intero lungometraggio è di conseguenza basata sulle caratteristiche principali dell’attrice tra il surreale e il perenne, costante «reale sublimato». Ne scaturisce una sovrabbondanza di primi e primissimi piani, un’insistenza quindi – al limite del didascalico – sulla malattia (la tisi) che ne infestò gli ultimi anni e l’imperitura lotta dell’artista contro un’attualità ostile o comunque in evidente stato di avanzato degrado culturale e politico (l’Italia lacerata tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo: esemplare in tal senso fu l’incontro con Mussolini). L’obiettivo dichiarato di prendere lo spettatore, sollevandolo letteralmente dalla sedia per immergerlo direttamente nello spirito, nella «verità artistica» della Divina, porta Marcello a costruire il film tra verità e finzione, facendo scivolare il teatro in qualcosa che non è né l’una né l’altra e la cui funzionalità al disegno registico risulta purtroppo vaga, debole.
Il rapporto della Divina con D’Annunzio sembra soffrire della stessa patologia, laddove l’inserto di Giordano Bruno Guerri nei panni dell’assistente del poeta vate risulta invece riuscito proprio in quanto icastico. Lo sguardo, l’intensità sobria e allegorica di Bruni Tedeschi e la sua recitazione unilateralmente surreale tratteggiano un personaggio «che brucia nell’Arte», immerso in modo esclusivo nel suo mondo a parte, alieno alle circostanze terrene, materiali, da cui rifugge.
Ma sul grande schermo tutto questo raggiunge l’effetto di far perdere Duse in una nebbia simile a quella con cui si chiude il film, serrandola in un’aura di irrealtà. Al contrario di tutto quello che è stato il teatro della Divina: costruire una seconda natura, lavorando il corpo e il movimento nei minimi dettagli, con grande complessità nel suo lavoro, simile a quello di un grande scultore o di un grande pittore, capace di tessere contrapposizioni sottili, che non saltano agli occhi a prima vista, ma agiscono lentamente su chi guarda e in scena creano una scossa esistenziale. Qualcosa di vivo, tangibile. Trattandosi di un’artista storicamente esistita, l’operazione filmica, che ha una sua coerenza interna e spicca per originalità, può suscitare legittime perplessità.
Infine, siamo portati a chiederci se a volte l’anelito all’Arte pura, sebbene autentico e condivisibile, tenda (troppo?) in alto, quando è di materia che, specie in teatro, i sogni – e i miti – son fatti.