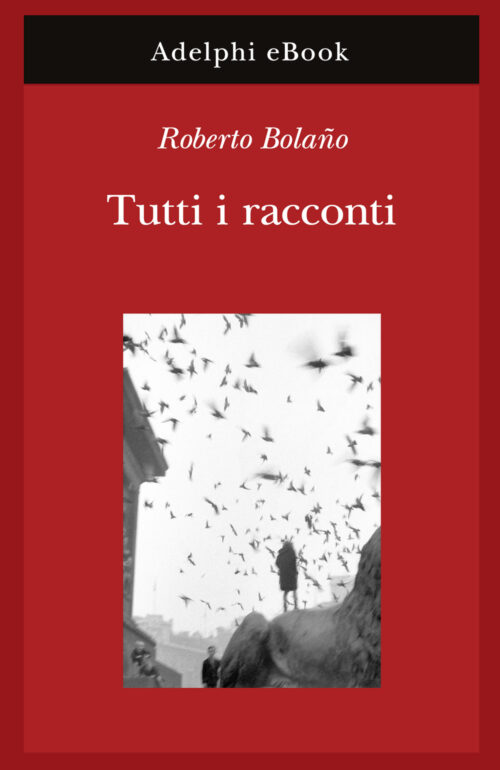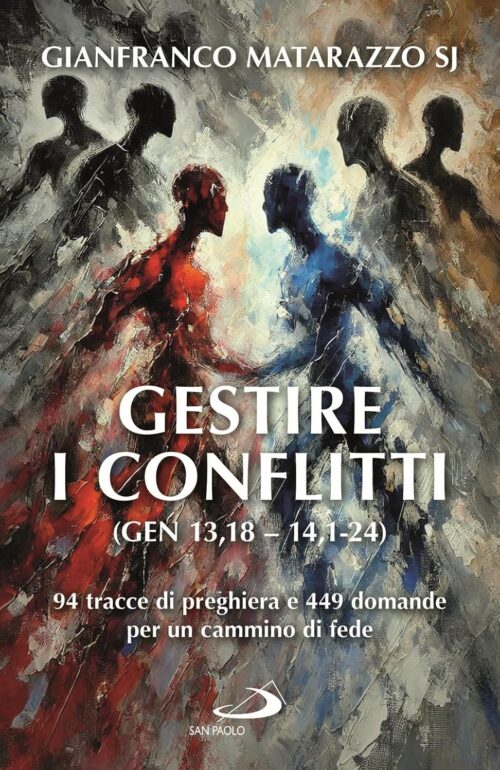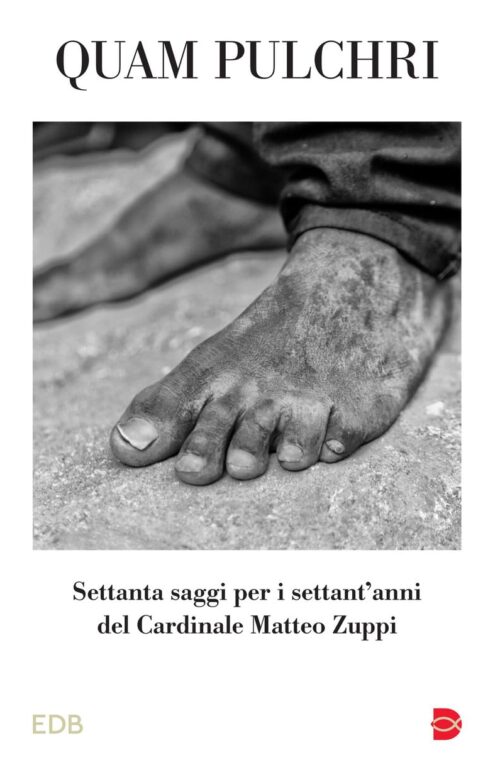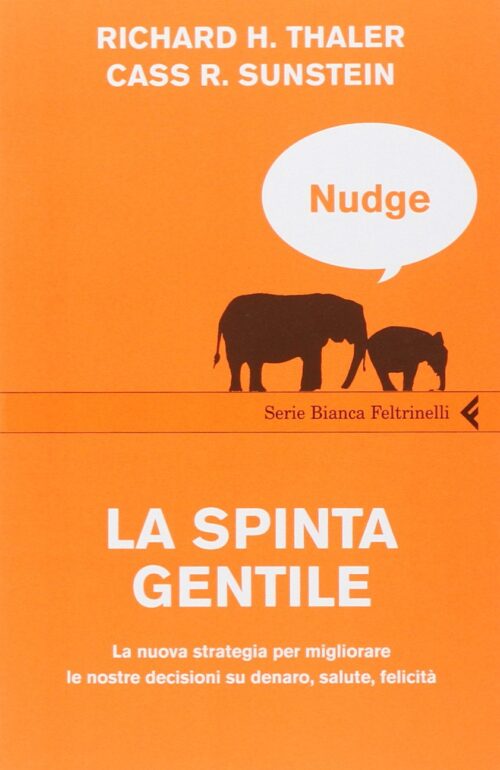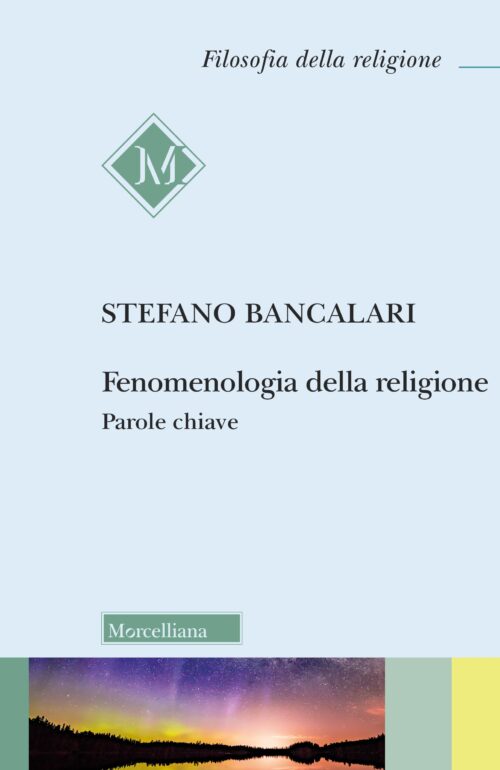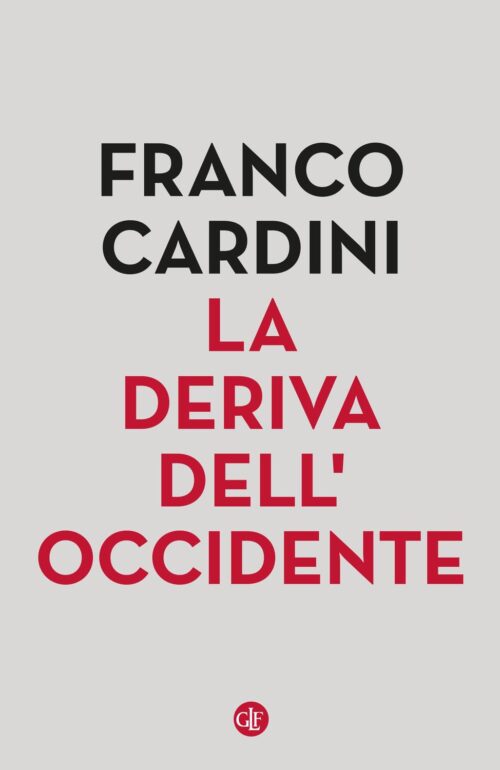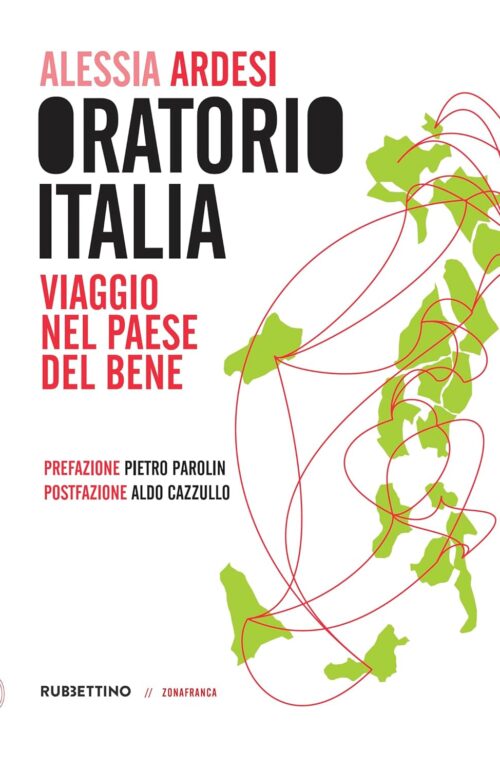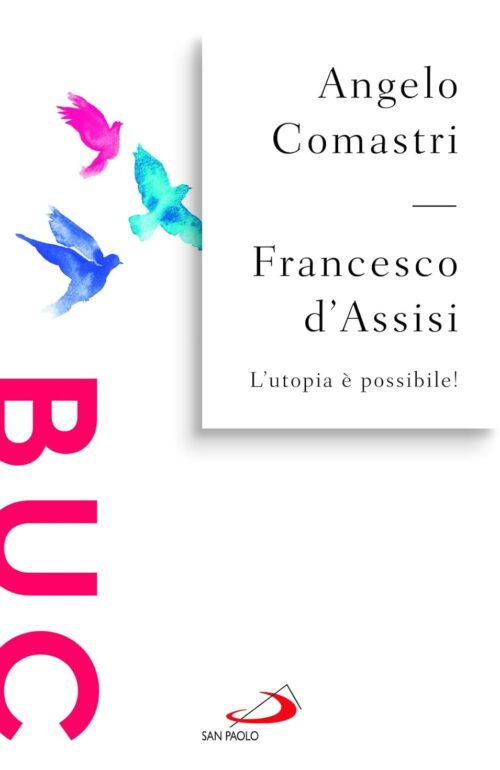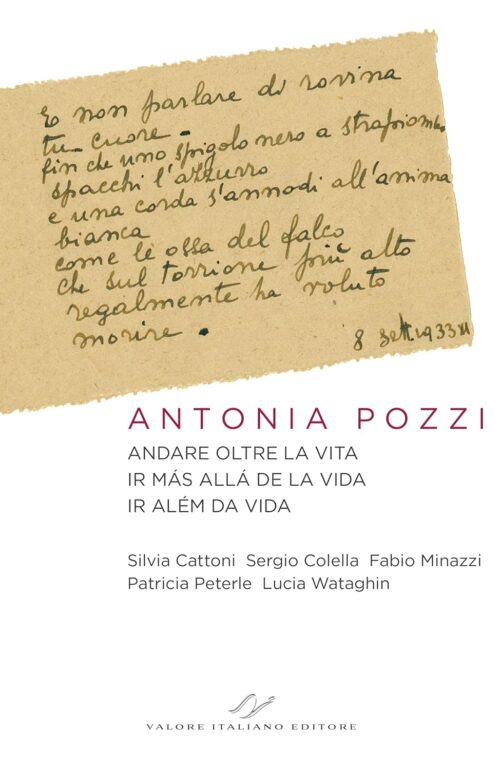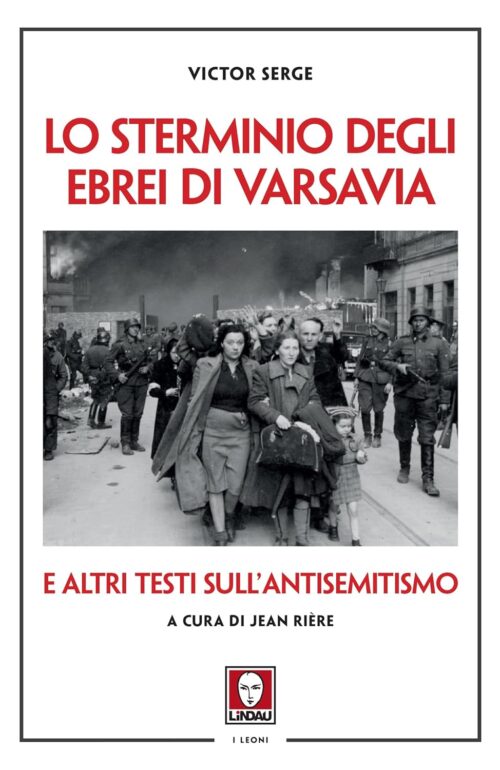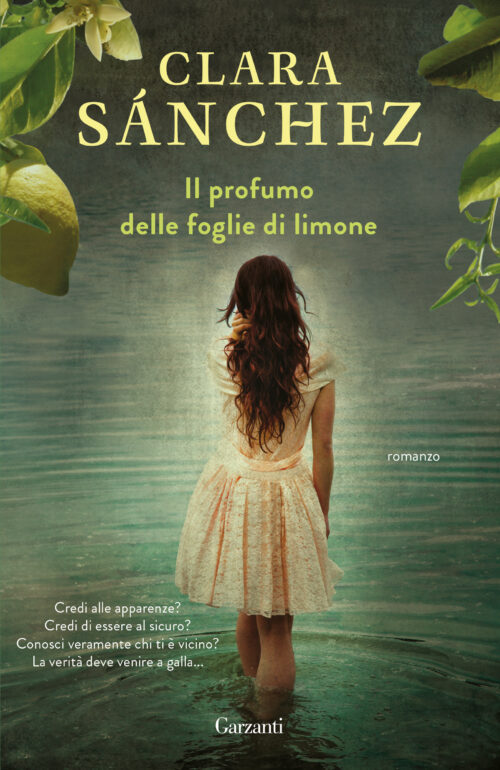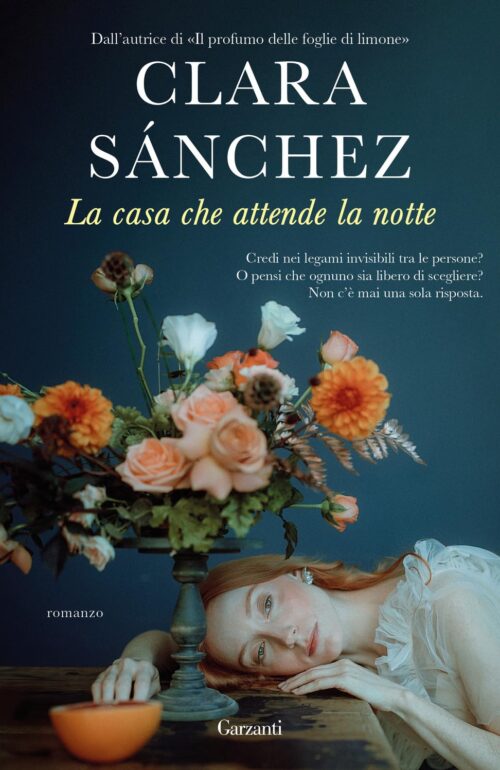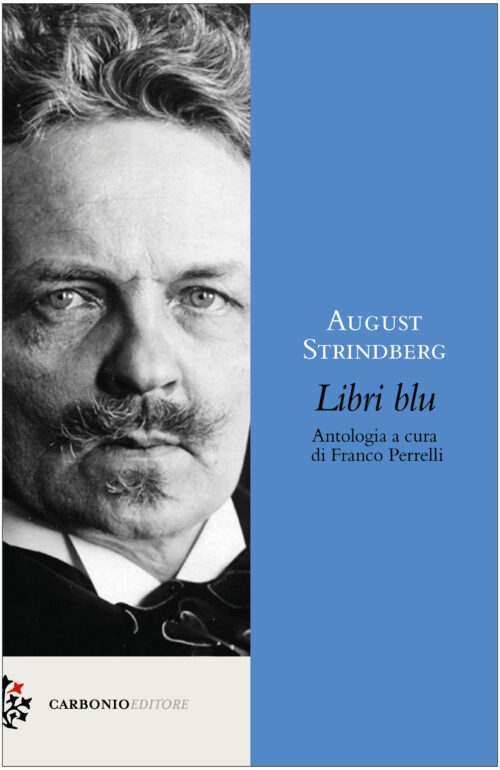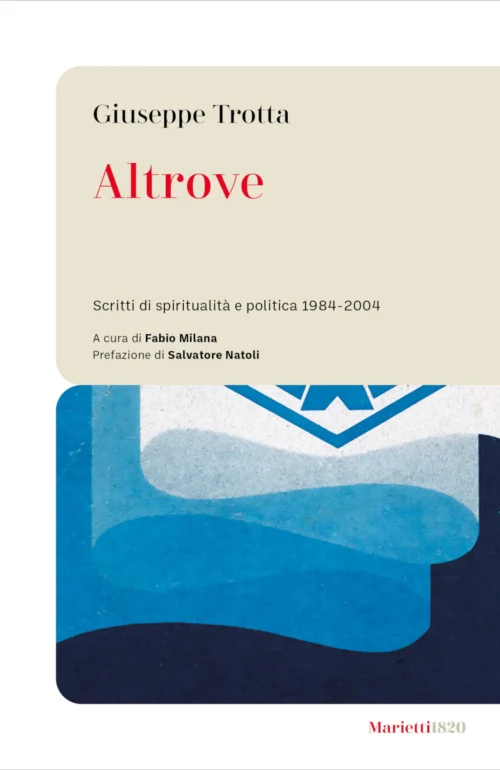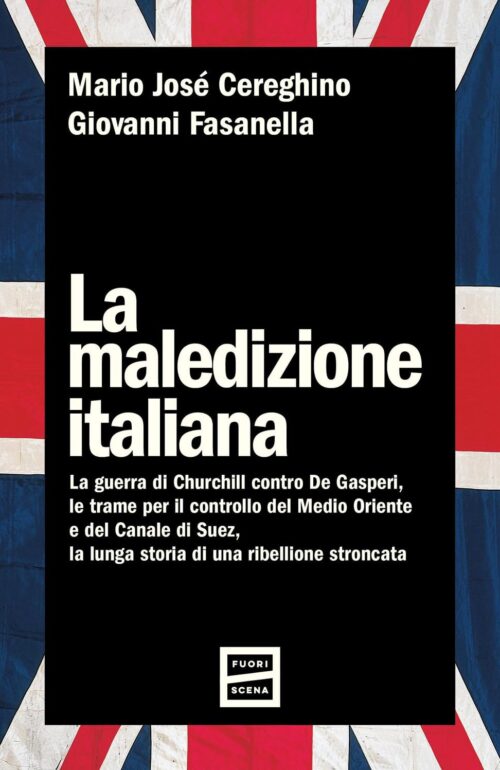A 70 anni dalla monografica vaticana su Beato Angelico e a 500 anni dalla morte del pittore, si inaugura una nuova mostra a lui dedicata, a cura di Carl Brandon Strehlke, Stefano Casciu e Angelo Tartuferi, che da quattro anni lavorano all’esposizione di 140 opere allestite tra Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco, a Firenze.
Fra Giovanni da Fiesole, passato alla storia come Beato Angelico (beatificato al tempo di san Giovanni Paolo II, nel 1982, e chiamato «Angelico» per la prima volta da fra Domenico di Giovanni da Corella per l’Armadio degli Argenti da lui dipinto, esposto nella mostra), è stato il pittore che ha incarnato lo spirito tardo gotico della sua epoca, per poi superarlo, rendendosi portavoce del Rinascimento fiorentino. Il suo valore fu tale da essere desiderato anche a Roma: papa Eugenio IV lo chiamò in Vaticano per occuparsi della Cappella Niccolina.
Presso Palazzo Strozzi, le opere dell’Angelico dialogano con altri artisti della sua epoca, come Lippi, Monaco, Pesellino, per un confronto virtuoso. Un confronto che continua anche negli ambienti del Museo di San Marco, dove si aggiunge, oltre agli affreschi, una sezione interamente dedicata alle miniature, esposte nella biblioteca del convento.
La produzione artistica dell’Angelico è una sintesi dei valori rinascimentali; guardando ad essa, si comprende quali fossero le declinazioni del sacro all’epoca: l’arte è sempre più strumento di preghiera, spaziando da una dimensione comunitaria, liturgica, ecclesiale, a una che va facendosi privata, intima, personale, da coltivare tra le mura della propria casa.
Questa mostra, oltre al merito di aver riunito articolate pale d’altare, smembrate e diffuse nei musei del mondo, riconsegnandone la visione d’insieme, risalta anche per la drammaticità di alcuni passaggi. Dalla dolcezza dei volti delle Madonne, ci si imbatte frontalmente nella tristezza abitata negli occhi del Cristo come Re dei Re: una carrellata di labbra drammaticamente ricurve e occhi insanguinati di pianto smuove inevitabilmente il sentimento di compassione dell’osservatore. O ancora, la sezione dedicata alle crocifissioni sagomate, esempi di sintesi tra pittura e scultura, dà vita a un risultato plastico unico.
La matrice domenicana è determinante nel riconoscimento delle opere dell’Angelico: il dialogo con Dio, lo studio dei testi di san Tommaso e sant’Agostino, le mistiche e tutto il sapere teologico e scientifico approfondito condizionano un modo di meditare e contemplare. La sensibilità di spirito, assieme all’abilità pittorica, ha permesso di dare forma al dialogo personale che fra Angelico nutriva e alimentava con il Signore. Ne deriva un linguaggio di una tenerezza sconcertante: l’uso dei colori è accogliente alla vista, una dolcezza cromatica che guida verso la forza del gesto, delle espressioni nei volti e nelle pose così squisitamente umani. L’Angelico è rivoluzionario proprio nella misura in cui riesce a calare il divino nell’umano, a partire dall’uso della prospettiva, rendendo in materia pittorica la preghiera domenicana che sorge dal silenzio, nella contemplazione del Logos incarnato.
Beato Angelico interpreta il Mistero in pittura, come si può capire dagli affreschi delle celle e dei corridoi del convento di San Marco. Le immagini si presentano come una visione: dal candore dei muri bianchi «si apre» un varco – che sia una scena della vita di Cristo, una crocifissione con san Domenico in preghiera o episodi dei Vangeli –, a seconda della destinazione delle celle. Il passaggio da una cella all’altra è un vero e proprio percorso meditativo, in cui non ci si sente mai abbandonati da Cristo: nella cella destinata a Cosimo de’ Medici e abitata anche da Eugenio IV, nell’immagine dell’Adorazione dei Magi è inserita una nicchia con il Cristo risorto; scavando nel cuore della terra, nelle profondità degli abissi, lui c’è, ed è commovente.
Utilizzando i termini di Didi-Huberman (che ha studiato ampiamente l’artista), possiamo dire che la pittura di fra Angelico è devota e sottile; talvolta enigmatica, quasi contemporanea, fintamente didascalica, ma fortemente simbolica e mistica. Le sue opere sono rivelazioni commoventi, le cui figure sono custodi di un non-tempo e non-spazio che riportano a quella profondità esplorata da sant’Agostino, la mira profunditas, che traghetta dalla paura al tremor amoris chiunque vi si accosti.