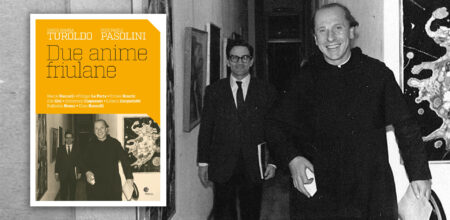Il contributo dell’antropologia
Uno degli scopi dell’antropologia è favorire l’autocomprensione dell’essere umano, cioè attivare un processo di consapevolezza delle dinamiche esistenziali e culturali nelle quali egli si trova a vivere. Si tratta di un processo liberante, perché permette di scegliere chi vogliamo essere piuttosto che subire passivamente i cambiamenti che avvengono dentro di noi e attorno a noi.
Un limite dell’antropologia è dato però dal fatto che essa può fornire solo chiavi di lettura, in virtù della complessità dell’essere umano e per la varietà delle condizioni sociali in cui vive, nonché per quella dimensione di mistero che è ineliminabile in ogni persona. Possiamo quindi descrivere quelle dinamiche che più o meno sono presenti in ognuno di noi, senza la pretesa che siano esaustive o che vengano vissute sempre nelle stesse modalità.
Una delle possibili chiavi di lettura è la comprensione del nostro tempo come un passaggio dall’epoca del logos, inteso come centralità della ragione analitica ed esaltazione di una logica stringente quale struttura fondamentale della comunicazione, all’epoca del pathos, cioè del riemergere in modo strabordante dell’espressione emotiva.
Questa distinzione appare analoga a quella che Friedrich Nietzsche individuava, in senso inverso, a proposito della nascita della tragedia, tra il dionisiaco e l’apollineo. Vorremmo dunque ripartire da questa intuizione di Nietzsche per comprendere in che modo la nostra epoca possa essere considerata come il trionfo del dionisiaco, che effettivamente egli aveva previsto. Ripercorrendo le osservazioni del filosofo tedesco, emergerà anche la via possibile per una ricomposizione vitale di quella frattura tra ragione ed emozione che abita oggi il cuore dell’uomo.
Dionisiaco e apollineo
Sebbene Nietzsche sia ritornato più volte sulla relazione tra questi due termini, di fatto è ne La nascita della tragedia[1] che egli presenta lo sviluppo dell’arte, a partire proprio dalla tragedia antica, attraverso la relazione tra il dionisiaco e l’apollineo. Si tratta innanzitutto di una coppia di termini che non è semplicemente antitetica, ma fraterna. Dionisiaco e apollineo sono infatti due istinti che si manifestano in ogni arte, benché si fondino e si concilino solo nella tragedia attica, e in modo specifico, secondo Nietzsche, solo nell’opera di Eschilo.
Dal punto di vista dei generi artistici, una prima distinzione, presente già in una conferenza del filosofo del 1870[2], è quella tra le arti visive, che sono maggiormente espressione dell’istinto apollineo, e l’arte musicale, che manifesta invece pienamente lo spirito dionisiaco. I cortei dionisiaci sarebbero infatti la culla del dramma antico, che era costituito
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento