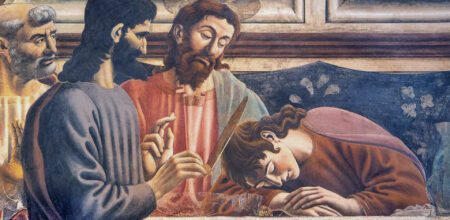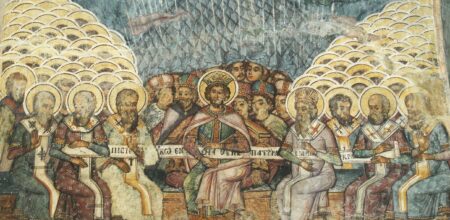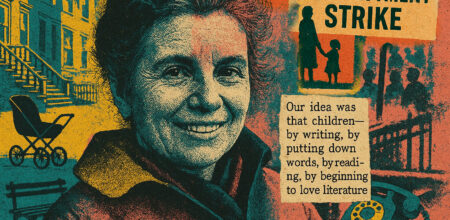Introduzione
Papa Francesco ha posto la speranza al centro dell’Anno giubilare 2025. Nella bolla di indizione del Giubileo, Spes non confundit[1], esprime il desiderio che esso sia un’occasione di rinnovata speranza nei cuori degli esseri umani. Per i cristiani, questa speranza, che mantiene viva la fiducia nella felicità futura nonostante le incertezze e le difficoltà della vita presente, deriva più direttamente dal «Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto», dalla rivelazione dell’amore di Dio, «l’amore che scaturisce dal cuore di Gesù trafitto sulla croce».
Per alimentare ulteriormente la speranza, papa Francesco invita la Chiesa a leggere «i segni della speranza» nel mondo, in linea con l’attenzione ai segni dei tempi promossa dalla costituzione pastorale Gaudium et spes (GS). «Porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo» è un antidoto alla tentazione «di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza». Tra questi segni di speranza, il Pontefice colloca al primo posto il desiderio di pace.
È quindi una felice coincidenza che nell’anno 2025 si celebri anche il 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, un testo nato da un ardente desiderio di pace. Era infatti il 9 maggio 1950 quando Robert Schuman, allora ministro degli Affari esteri della Francia, durante una conferenza stampa al Quai d’Orsay, rese nota una proposta rivolta alla Germania. La Francia prospettava di gestire congiuntamente i mercati del carbone e dell’acciaio in una modalità nuova, di carattere sovranazionale; tale proposta non era rivolta solo alla Francia e alla Germania, ma doveva essere estesa a tutte le parti interessate. Il progetto, concepito dalla mente lungimirante di Jean Monnet, intendeva offrire una vera e propria via d’uscita ai Paesi europei all’indomani della Seconda guerra mondiale e prevenire soluzioni che avrebbero potuto aggravare le divisioni e rafforzare i sospetti, invece di sanarli. I princìpi della Dichiarazione Schuman di fatto costituirono il punto di partenza e il modello per lo sviluppo di quella che sarebbe diventata dapprima la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, poi la Comunità europea e, infine, l’Unione europea (Ue). Quel giorno può quindi essere considerato fondativo del progetto di integrazione europea, e per questo il Consiglio d’Europa nel 1985 ha proclamato il 9 maggio «Giornata dell’Europa».
Settantacinque anni dopo, tornare al testo della Dichiarazione e ai suoi princìpi fondamentali è ancora fonte di ispirazione. Per molti versi, i temi sviluppati da Schuman e Monnet – come la pace, la riconciliazione, il dialogo, la giustizia equa, la pazienza, per citarne
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento