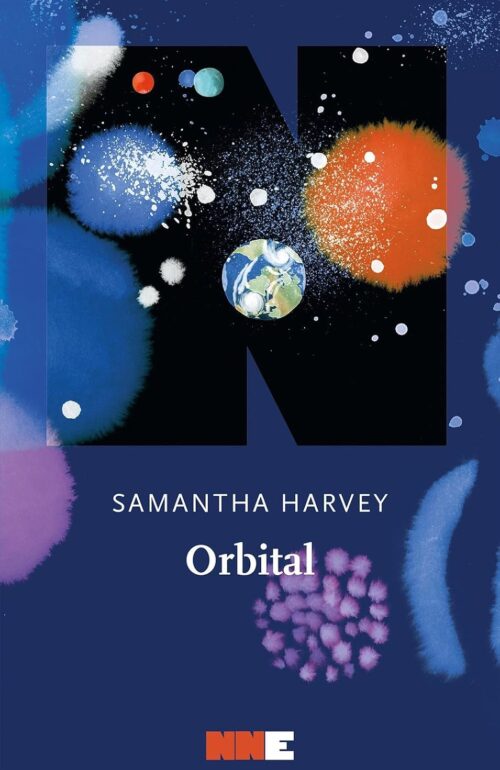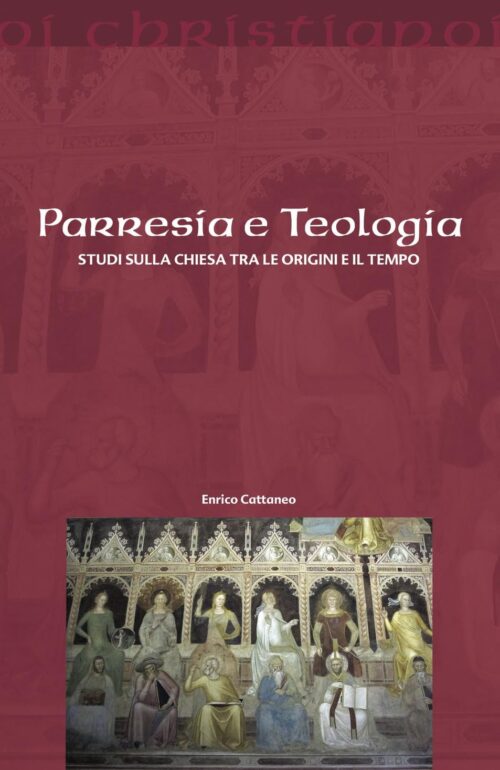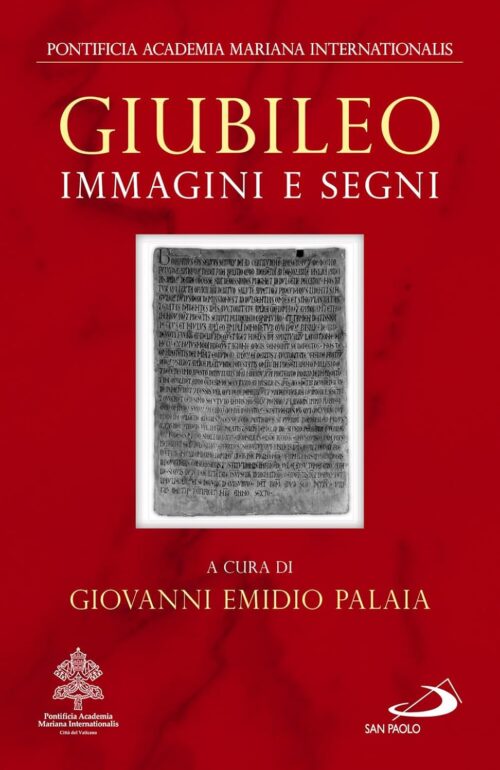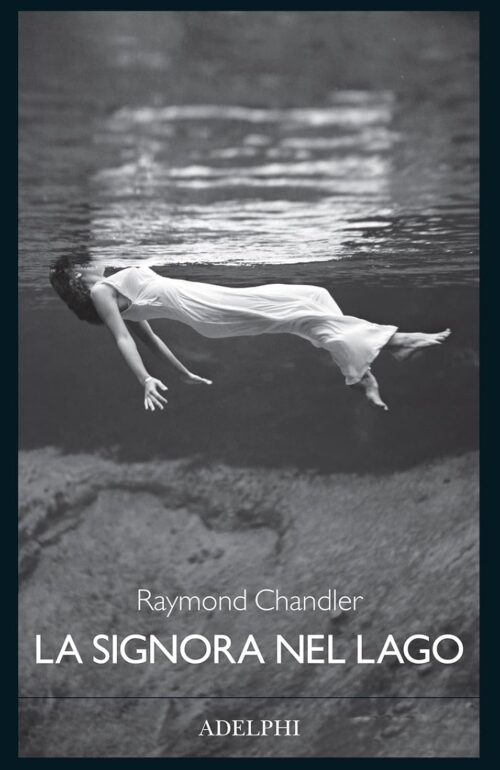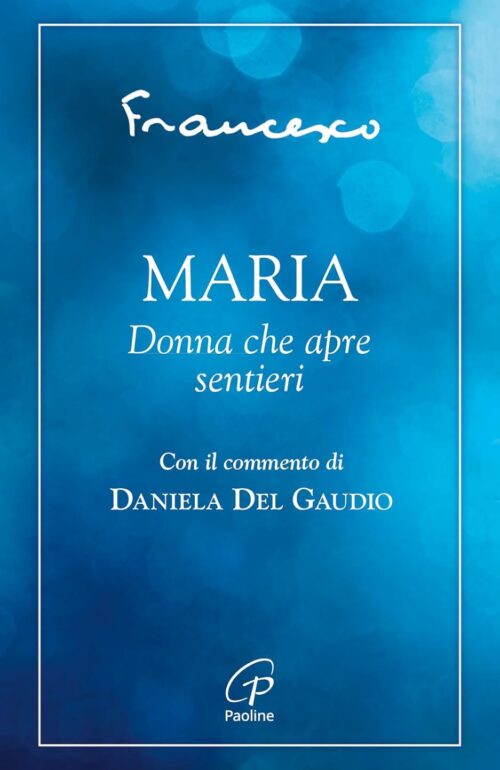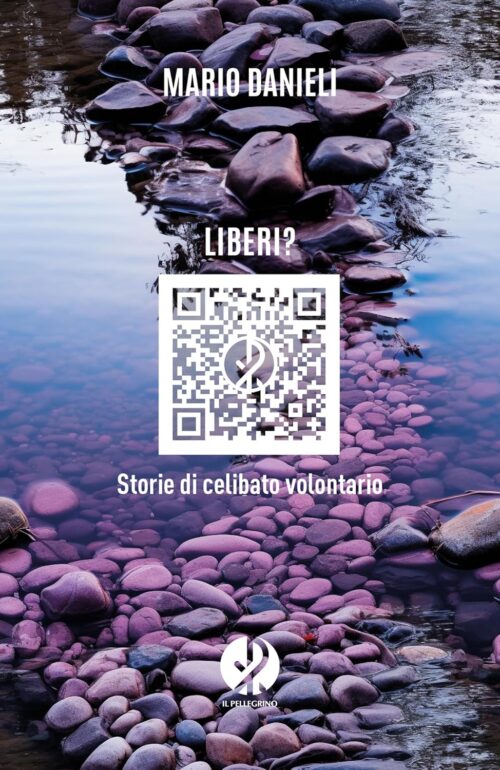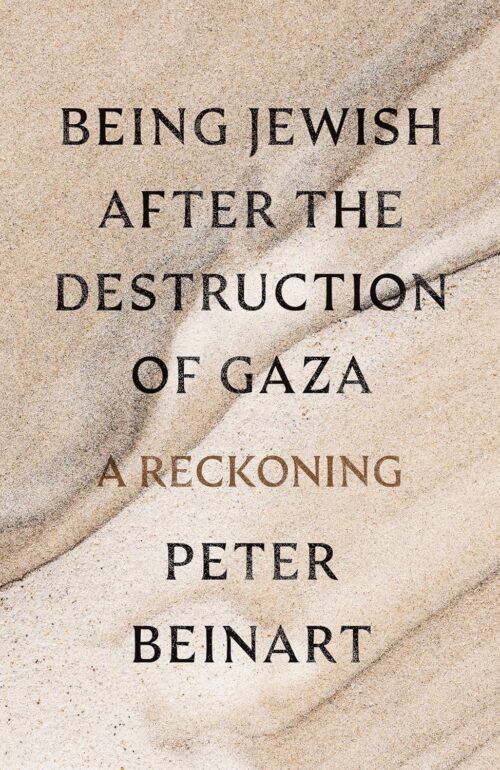Raccontare l’orrore è una scelta etica, ma è anche la vocazione di coloro che sono ritornati dall’inferno. Ma con quale lingua? Con quali forme, quali colori? In prosa, in poesia, attraverso l’istantanea di una macchina fotografica o una tela dipinta? C’è una lingua del dopo, una tessitura di parole spezzate. Incomprensibile ai più, la lingua dei «salvati» non conosce traduzioni possibili, è una lingua frantumata.
Molti testimoni del passato hanno scelto il silenzio, altri hanno tentato di raccontarsi per testimoniare, per non dimenticare. Primo Levi, nella carcerazione del lager nazista, ricevette una vocazione alla testimonianza. Egli afferma che fu «l’esperienza del lager a costringermi a scrivere». Paul Celan, anch’egli perseguitato e incarcerato nei campi di lavoro in Romania, parla invece di una lingua ormai definitivamente compromessa per dire. C’è qualcosa di verbalmente impossibile nel tentativo di dare forma all’insensata esperienza della brutalità. Solo il balbettio, come incedere esitante e spezzato della voce, può restituire qualcosa delle vite frantumate dalla barbarie nazista. Quale arte può allora raccontare le tragedie della Siria, del Medio Oriente, delle carceri di Guantanamo? Solo un’arte che abbandoni la presunzione di descrivere, utilizzando forme chiare e distinte.
Non è l’artista che frantuma le forme e il colore. Il colore si è definitivamente dissolto nei campi di concentramento, nei gulag, nelle prigioni, dove uomini e donne sono stati torturati e privati dei diritti più elementari. Dopo Auschwitz i colori sono cambiati. Negli occhi del poeta, dell’artista, del testimone non c’è posto per il giallo delle ginestre, l’arancio degli agrumi, il verde chiaro dei campi primaverili. E come potrebbe un dipinto descrivere con esattezza le forme scomposte della violenza? Frantumati sono i pennelli, le tele, lo sguardo, le parole: non è un’arte frammentata, è una vita in frantumi.
Così Najah al-Bukai, con i suoi disegni pubblicati nell’agosto del 2018 sulle pagine del quotidiano francese Libération, ha tentato di dare testimonianza delle violenze subite nelle carceri siriane. La violenza deforma e abbrutisce; non c’è colore, solo un tratto esile e incerto di biro per non dimenticare, per tentare di emanciparsi dalle atrocità subite. E il colore? Ma non è troppo il colore per raccontare la violenza? Perché l’artista dovrebbe mai aggiungere colore all’esistenza incolore di un condannato? Nella volontà di testimoniare ciò che ha vissuto finirebbe per tradire la ferocia subita. Una cella senza luce, grida, torture, speranza minima.